In tutta la vita stavi solo aspettando
che questo momento arrivasse
(Blackbird, Lennon-McCartney, 1968)
«Anche la cassa destra verso il soffitto!», ordinò Giovanni.
«Sicuro?»
«Te l’ho detto, la punta del triangolo deve essere il lampadario.»
Capita a tutti, almeno una volta, di avere il potere di cambiare gli eventi definitivamente. A me è successo il nove agosto del ’79, più o meno alle nove di sera, mentre ero seduto al buio ad ascoltare il White Album circondato da candele rosse. Perché vi dico questo? Perché lo so che anche voi avreste bisogno di una rivoluzione ma, di certo, non potete sapere che per ottenerla è sufficiente ascoltare nove volte consecutive la #9 dei Beatles e poi rigirarla.
«Nove?», dissi come fosse una stupidaggine.
Giovanni fu convincente: «Leggi che c’è scritto» e scandì bene: «Revolution number nine. E noi la ascolteremo nove volte, poi invertiremo il disco e vedremo se ho ragione.»
Dopo gli esami di terza media, con Giovanni avevamo passato più di un mese a raccogliere indizi su un quadernone e a discutere di quello che chiamavamo Il Progetto PID, che stava per Paul Is Dead. Eravamo convinti di poter smascherare il più grande complotto del rock: Paul McCartney era morto in un incidente d’auto ed era stato sostituito da un sosia che aveva ingannato tutti ma, e qui veniva il bello, John Lennon aveva lasciato disseminati nelle canzoni e nelle copertine degli LP piccoli indizi che spiegavano la verità. Qualche esempio?
Posizionando uno specchio sulla grancassa, a metà della scritta Lonely Hearths dell’album Sgt Pepper’s si poteva leggere chiaramente la data dell’incidente di Paul: il nove novembre del ’66. Inoltre, nella foto posteriore di quell’immenso affresco floreale, Paul era molto più alto e robusto degli altri ed era l’unico inquadrato di spalle.
«Si vede che non è lui.»
E, se non bastasse, sul distintivo della sua giacca, c’era uno stemma con impresse le lettere OPD.
«Officially Pronounced Dead.»
«E che vuol dire?»
«Ufficialmente Dichiarato Morto.»
«Pensa te, e io che credevo fosse il distintivo della Polizia…»
E questo non era ancora niente se paragonato alla foto di Abbey Road, «L’ultimo album prima dello scioglimento definitivo». Lì John, Ringo, Paul e George sono fotografati mentre attraversano le strisce pedonali. Abbey Road non è una strada qualsiasi perché si trova di fronte agli studios dove i Beatles registrarono tutte le loro canzoni.
«Ti rendi conto? Non stanno “attraversando”, stanno “uscendo dagli” studios. Per non tornarci più.»
Guardando attentamente l’immagine si capiva subito che qualcosa non andava e quel qualcosa era, cito a memoria dal nostro quadernone:
UNO: John vestito di bianco (come un sacerdote) seguito dagli altri tre (come in un corteo funebre),
DUE: l’insolito aspetto di Paul: scalzo, con gli occhi chiusi e la sigaretta nella mano destra (dettaglio singolare se si pensa che era mancino), e poi
TRE: la targa dell’auto parcheggiata dietro. Si leggeva chiaramente 28IF e quello era, ovviamente, un messaggio di John: 28 sarebbe stata, infatti, l’età di Paul “se” fosse stato ancora vivo al momento dell’uscita di (nonché da) Abbey Road. Insomma, altro che Yoko Ono, altro che rivalità e carriere soliste… Era solo questione di tempo e con Giovanni avremmo dimostrato il vero motivo per cui si erano sciolti i Beatles.
«Moriremo asfissiati.»
«Non si muore asfissiati con le candele.»
«Forse perché queste si accendono quando uno è già morto.»
«Cos’è? Ora che ci siamo hai paura?»
«Figurati se mi fanno paura nove ceri rossi.»
«Allora passami il disco…»
La madre di Giovanni entrò senza bussare e si precipitò verso la finestra spalancandola: «Ma non vi vergognate?»
La madre di Giovanni era sempre nervosa, ma quel pomeriggio lo era più del solito. Nella stanza di sopra si consumava l’ultimo atto di una tragedia che andava avanti ormai da troppo tempo: il vecchio nonno stava morendo. Per il medico ogni giorno poteva essere l’ultimo. Addirittura ogni ora. I figli aspettavano la notizia solo per l’eredità e la mamma di Giovanni era vicina all’esaurimento perché non poteva annunciare il triste evento.
«Se sento solo un rumore è meglio che non vi fate trovare qua dentro.»
Non ci facemmo intimidire e richiudemmo la finestra. Stavamo per ascoltare Revolution #9, la penultima canzone del secondo LP del White Album. Quella con la voce che ripeteva “number nine” e, al contrario, “turn me on dead man” cioè, letteralmente, una cosa tipo “eccitami uomo morto”.
Nessuno sapeva cosa significasse, tranne Giovanni, che mi avrebbe spiegato tutto dopo l’esperimento con il giradischi e le candele.
«Tempo?», chiese Giovanni con la puntina dello stereo pronta sul disco e la faccia in penombra.
«Nove per nove 81, un’ora e ventuno minuti», risposi con il quadernone aperto e la matita in mano.
«Perfetto. Se i miei calcoli sono esatti finiremo esattamente alle nove e nove minuti.»
«81 minuti: 8 + 1 = 9, il nostro numero difettivo preferito.»
«E non solo il nostro…»
«Perché?»
«Nove è il numero del diavolo.»
«Guarda che sei è il numero del diavolo.»
«Esatto: 666 cioè 6 + 6 + 6. Cioè 18 e quindi 8 + 1»
«…»
Scrissi un po’ preoccupato: «Revolution #9. Primo ascolto.»
Tutti i non esperti commettono l’errore di confondere Revolution #1 con Revolution #9.
La prima è quella con John che canta “dici che vuoi la rivoluzione? Beh sai, tutti noi vogliamo cambiare il mondo”. Pura poesia, anche se noi preferivamo la versione più veloce e graffiante su Hey Jude, quella dove Paul urla e John è più incazzato del solito. Revolution #9, invece, è un pezzo strumentale di 9 minuti. Era molto importante per il Progetto PID anzi, un vero punto di non ritorno tanto da convincere Giovanni che, se ascoltato al contrario, avrebbe potuto sprigionare potenti campi magnetici.
«Schhh… inizia!»
Mi concentrai e scrissi ciò che ascoltai: il suono gracchiante del vinile, una conversazione incomprensibile, una melodia al pianoforte che si sviluppava intorno a un mi minore e poi una voce da speaker che ripeteva “number nine, number nine, number nine”. Scrutai il viso attento di Giovanni. La #9 proseguì con sette lunghi minuti di rumori. Riconobbi grida e frammenti di musica orchestrale. Poi un clacson e una frenata.
«Hai sentito?», sorrise Giovanni: «John ci ha descritto l’incidente di Paul!»
Era felice come se mi avesse appena comunicato il codice per decifrare la Stele di Rosetta. Annuii serio e continuai a prendere appunti nel semibuio lugubre della stanza. Il pezzo arrivò alla fine e iniziò Good Night, l’ultima traccia: una ninna nanna di John cantata da Ringo, ininfluente sia per il PID che per la discografia dei Beatles.
Giovanni spostò delicatamente la puntina e la #9 ripartì con la conversazione, il piano in mi minore, e number nine.
La storia della morte di McCartney non mi aveva mai convinto: secondo me Paul e gli altri si erano divertiti un casino a inventare falsi indizi per alimentare la leggenda. Giovanni però vedeva una cospirazione di proporzioni cosmiche e, ogni volta che arrivavamo a questo punto della discussione, riapriva il quadernone del Progetto PID e mi mostrava le foto di Sgt. Pepper’s con la scritta Lonely Hearths e Abbey Road con la targa 28IF, nonché le dettagliate schede dei testi di tutte le canzoni contenenti doppi o tripli significati che avevamo scovato ascoltando i dischi usciti dopo l’incidente di Paul. Poteva andare avanti per ore e, alla fine, accettavo sempre la sua teoria più per sfinimento che per convinzione.
La traccia finì e ripartì: «Altri 63 minuti e ascolteremo number nine al contrario!»
«Sicuro di volerla ascoltare nove volte?»
«Sì.»
«Perché non facciamo una pausa?»
«Impossibile.»
«Mi manca l’aria. Moriremo asfissiati e al buio.»
«Non moriremo. E tu mi ringrazierai per averti fatto saltare pianoforte.»
«Se i miei lo scoprono mi mettono in punizione per un mese.»
«Meglio, così lasci perdere il piano e ti compri una Fender, come quella di John.»
«Revolution #9: terzo ascolto.»
Capii solo quel pomeriggio cos’era che mi faceva così paura del White Album.
Non il fatto che fosse il disco numero nove dei Beatles. Sì, lo so che in realtà era il decimo ma in questo appoggiavo in pieno Giovanni perché neanche io credevo che i primi due potessero essere considerati separatamente, e non per la vicinanza di pubblicazione no, ma semplicemente per il fatto che le canzoni scritte da Lennon-McCartney erano così poche da non riempirne nemmeno uno di disco. Non era, dunque la presenza del numero nove che tanto eccitava Giovanni a spaventarmi.
«E sai di quante lettere è composto il cognome di Paul?»
«…»
«Esatto.»
E neppure tutte le corrispondenze trovate nelle canzoni che sembravano portarci dritti dritti alla #9, come John che sussurrava “Paul è l’uomo morto: mi manca…”
«Revolution #9: quarto ascolto.»
E, visto che ci siamo, non era nemmeno la vecchia storia del serial killer che aveva fatto violentare e uccidere famosi ricconi di Hollywood scrivendo sui muri con il loro sangue i titoli di un paio di canzoni del White Album (per dovere di cronaca: Piggies e Helter Skelter). Quel nano strabico e semianalfabeta ci aveva solo fatto incazzare di brutto. Come si era permesso di infangare con i suoi psicopatici deliri di onnipotenza la nostra band preferita?
«Revolution #9: quinto ascolto.»
No, a terrorizzarmi era un elemento all’apparenza innocuo e senza alcuna importanza: il fatto che il White Album fosse completamente bianco. Giovanni credeva di conoscere anche il motivo della mia inquietudine cromatica: «Per gli indiani, il bianco è il colore del lutto, della morte e dei fantasmi e, pensaci bene: quando hanno pubblicato il disco?»
«Dopo essere tornati dal viaggio di meditazione in India?»
«Già.»
Niente sembrava casuale.
«È normale che tutto quel bianco terrorizzi.»
Ma non era solo quello.
Il bianco accecante, l’assenza totale di qualsiasi elemento grafico a cui appigliarmi destabilizzava e minava le certezze conquistate con tanta fatica in più di un mese di lavoro sul Progetto PID: «E se John ci stesse dicendo che gli indizi non sono mai esistiti? Che non c’è mai stato nulla da trovare?»
«E se invece ci stesse invitando ad andare oltre la superficie e a cercare all’interno del disco?»
Certo, in quel caldo pomeriggio del ’79, al buio della sua cameretta, nemmeno la sofisticata e iperbolica cabala di Giovanni sarebbe arrivata a concepire che, l’anno successivo, un altro schizzato con in tasca Il Giovane Holden di Salinger avrebbe ucciso John sotto il portone di casa.
Il Giovane Holden.
L’unico libro dalla copertina totalmente bianca.
«Ok ripartiamo: Revolution #9: sesto ascolto.»
Secondo Giovanni, con la #9 i Beatles avevano provato a riportare in vita Paul ma non c’erano riusciti. Lui invece aveva capito come fare: «Si deve ascoltare nove volte la traccia prima di far girare il disco al contrario. Solo allora la preghiera della canzone diventa efficace!»
«Number nine è una preghiera?»
«Certo.»
Non capivo: «Ma efficace per cosa?»
Appoggiò la puntina con precisione millimetrica: «Per resuscitare i morti».
«Revolution #9: settimo ascolto.»
Secondo la lettura di Giovanni “eccitami uomo morto”, cioè “number nine” ascoltata al contrario, non era da intendersi come una metafora sessuale ma un canto di gioia per una avvenuta resurrezione. “Turn me on dead man” era John che diceva a Paul: «Ehi amico, torna e rendimi felice…»
«Che vuoi fare, riportare in vita il vero Paul McCartney?», chiesi ipnotizzato dai rumori orchestrali della #9.
«Che stupidaggine, e come potrei? Faremo solo un esperimento per capire se funziona.»
La #9 finì.
«Cambio!»
Giovanni venne a sedersi al mio posto e prese il quadernone mentre io andai al giradischi.
«Revolution #9: ottavo ascolto.»
La traccia procedette lenta. Ormai conoscevo a memoria tutti i passaggi: il piano, number nine, l’orchestra, il clacson, la frenata. Vicino allo stereo vedevo la puntina consumare i solchi del disco e i suoni materializzarsi in una sorta di pseudo-quadrifonia ottenuta grazie all’ingegnosa collocazione delle casse a 90 gradi verso il lampadario. Le note ci avvolgevano completamente insieme alla fuliggine cancerogena dei ceri e i minuti successivi passarono così, senza troppi pensieri finché non arrivammo al termine dell’ultimo ascolto: il nono.
«Adesso scopriremo se la nostra teoria è esatta!»
Mi feci coraggio e, su ordine di Giovanni, invertii il verso di rotazione del piatto e alzai il volume al massimo. Guardai la puntina scendere lentamente per l’ultima volta e chiusi gli occhi pensando a Claudia per evitare di scappare da quella stanza soffocante. Amavo Claudia ed ero sicuro che se fossi sopravvissuto alla #9 sarei riuscito certamente a baciarla. La puntina toccò delicatamente il disco. Il suono che si sprigionò era talmente forte da penetrarmi direttamente nel cervello: una strana onda sincopata che andava dalla cassa destra a quella sinistra fece tremare le pareti. I toni baritonali mi spaventarono. Sembravano voci cupe di spie del KGB. Poi “turn me on dead man” ripetuto tre volte con un forte accento al centro del pentasillabo: «turmeòndeadman turmeòndeadman turmeòndeadman», un accecante lampo di luce bianca e un fragore di vetri rotti e, dopo, buio e silenzio.
Secondi che durarono l’infinito.
Giovanni si avvicinò con un cero e vedemmo il disco che girava muto.
«Cazzo.»
Il lampadario era esploso lasciando un alone nero gigante. Giovanni non fece nemmeno in tempo a dire «Funziona!» che la madre irruppe sbraitando. Ricordo solo le schegge di vinile dalle forme irregolari che dalla testa di Giovanni si schiantavano sul muro e la mia corsa senza fiato per le scale e poi per strada con il White Album ancora caldo stretto al petto.
Più tardi seppi da un vicino che la madre non solo aveva strappato il quadernone del Progetto PID e aveva proibito a Giovanni di usare il giradischi per tutta l’estate ma che, nel suo impeto distruttivo, aveva frantumato Sgt. Pepper’s e Abbey Road e, non ancora pienamente soddisfatta, l’album rosso e quello blu, che era la mia raccolta preferita in assoluto.
Quella sera mia madre parlava al telefono sottovoce. Diceva che il nonno di Giovanni si era alzato dal letto e se n’era uscito di casa bestemmiando. Diceva che tutti erano rimasti sconvolti: «Un miracolo!» Diceva che la mamma di Giovanni non la smetteva più di piangere: «Sempre sia lodato.»
Comunque, l’estate finì prima che avessi trovato il modo di baciare Claudia e a settembre iniziai il liceo dimenticando tutto, distratto com’ero dai leggings delle ragazze più grandi e da una nuova passione: il punk. Il mio nuovo pantheon si riempì di divinità perverse sulle quali regnava indiscusso Joe Strummer insieme ai suoi Clash e, per quel che mi riguardava, chiusi il pianoforte, strappai i jeans e imparai a suonare una Strato bianca abbracciando una nuova filosofia riassumibile nell’assioma «’fanculo tutto!» e se ve lo state chiedendo sì, è vero, il vecchio Paul non è mai morto ma voglio dirvi una cosa: l’uomo sulle copertine dal ’66 in poi non è lui. Per un’estate credemmo che l’avessero rimpiazzato nella band, mentre invece la verità era che avevano fotografato un sosia, un doppione. Aveva ragione Giovanni: «Quello sui dischi è un impostore.»
FINE
—
L’autore ci tiene a precisare che la splendida illustrazione a corredo della storia, strettamente autobiografica, è stata realizzata da Emanuele Rosso, già autore di Passato, Prossimo (Tunué Editore). Per visualizzare l’illustrazione a tutto schermo è sufficiente cliccare sull’immagine o seguire il link.
Dell’autore di Revolutionine invece, se interessa, sempre su Maddmaths! è possibile leggere Viaggi nel tempo, istruzioni per l’uso e Il giorno in cui viaggiammo più veloci della luce (gli alieni parlarono in francese e ci dissero scemi)
© Diego Altobelli | www.revolutionine.com
Raccontino rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5






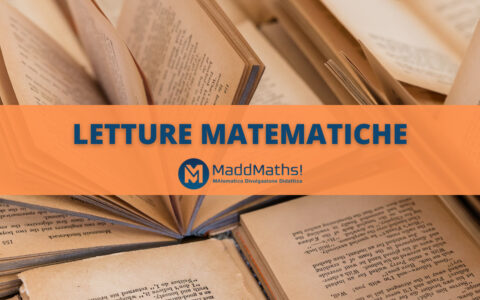



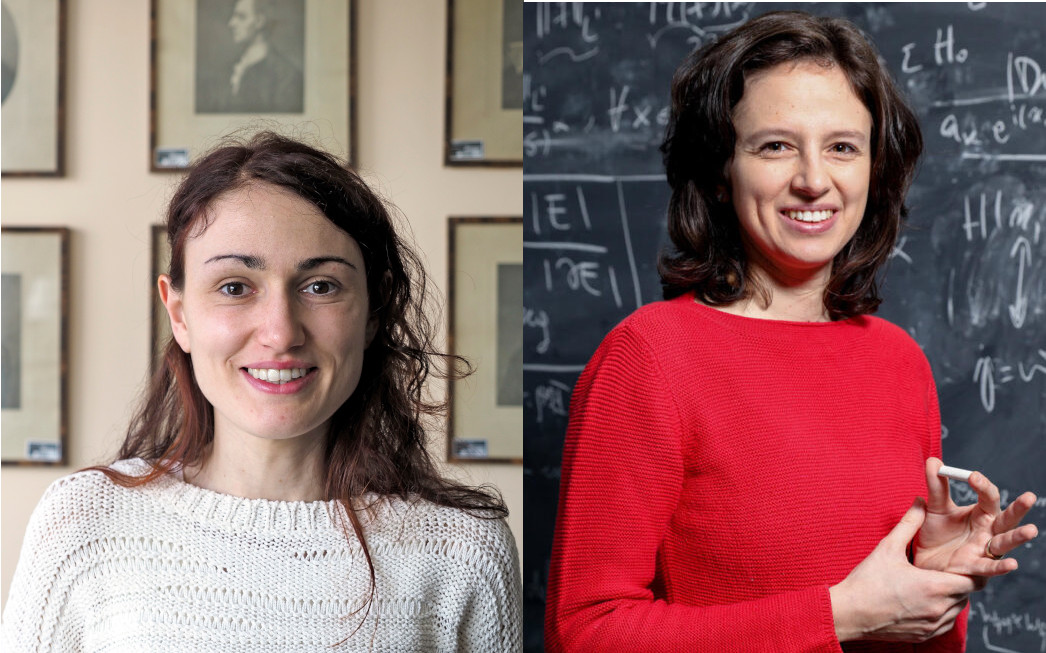


Troppo bello! Diego scrive da maestro. Adesso lo metto su (l’album bianco, una sola volta, però).