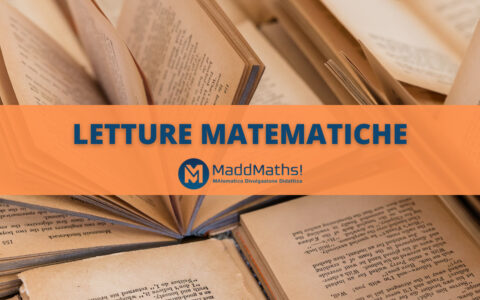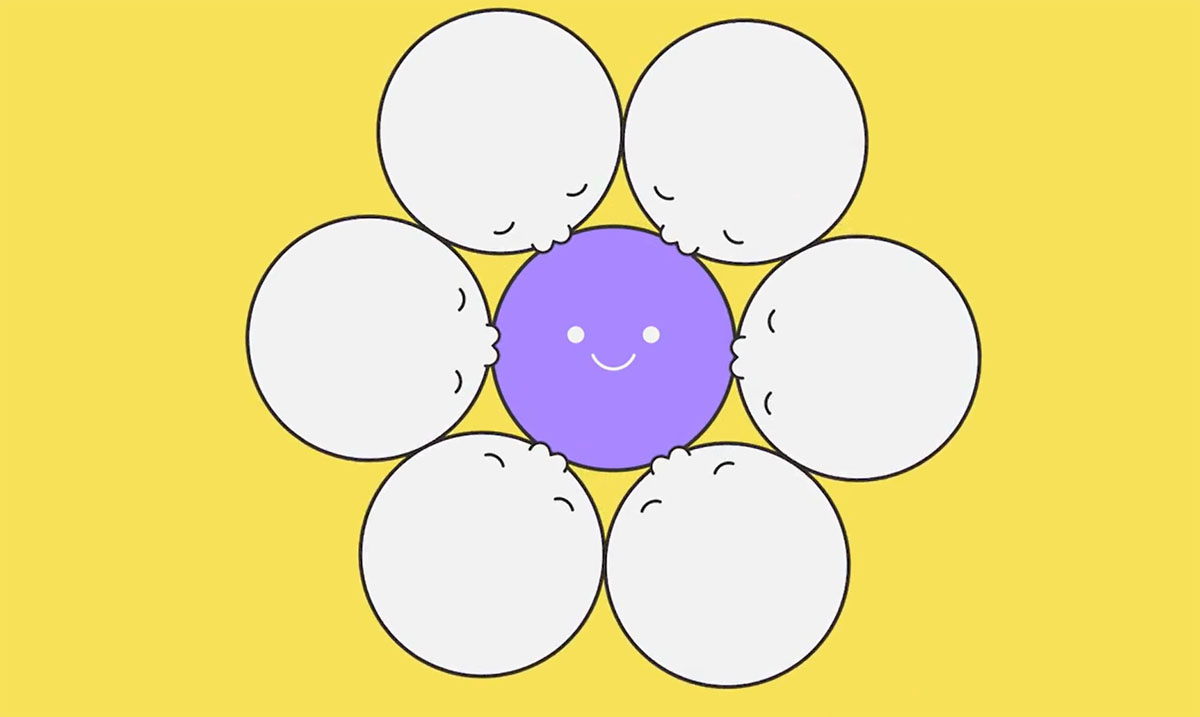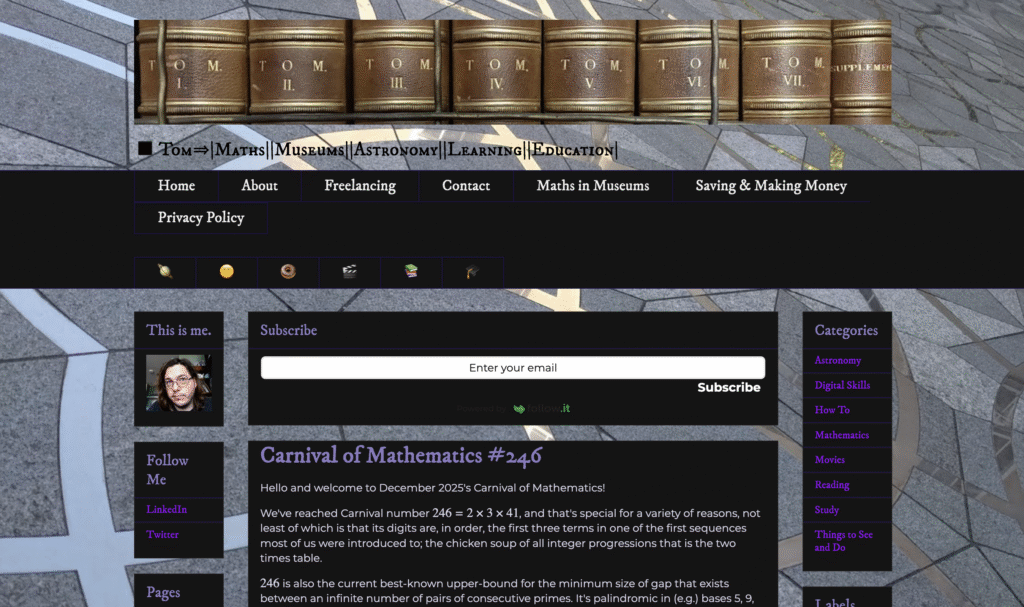L’ottimizzazione globale, la vita da tenure track nel profondo sud-est americano, l’industria e il team Xpress in UK. Pietro Belotti dell’AIRO ci racconta le sue esperienze da “ricercatore espatriato”.
Vorrei riassumere la mia esperienza da ricercatore espatriato. Ho conseguito un dottorato presso il Politecnico di Milano nel 2003 con una tesi sull’ottimizzazione delle reti di telecomunicazioni. Fino al 2006 ero assegnista nella stessa università e sono stato in visita per brevi periodi alla Bilkent University di Ankara, allo Zuse Institute di Berlino e all’École Polytechnique di Parigi. Nel 2006 mi sono trasferito negli States, e sono stato postdoc a Carnegie Mellon, poi Visiting Professor alla Lehigh University e dal 2010 al 2013 assistant professor al dipartimento di Mathematical Sciences della Clemson University, nella Carolina del sud. Nell’estate 2013 mi sono trasferito in Europa, a Birmingham (UK), dove sono sviluppatore nel team Xpress di Fair Isaac.
Volevo provare un’esperienza all’estero fin dalla fine del dottorato e ci sono riuscito nel 2006 cambiando argomento di studio: dai problemi di ottimizzazione di rete sono passato alla programmazione nonlineare intera, conosciuta anche come ottimizzazione globale. In quel momento era un argomento a me del tutto nuovo, ma mi piace molto e conto di lavorarci ancora a lungo.
Gioie e dolori del tenure track
Dopo due contratti a termine a Carnegie Mellon e Lehigh, a Clemson avevo una posizione di tipo “tenure track“: dopo un periodo di prova di cinque anni, l’università avrebbe deciso se darmi la “tenure”, promuovendomi ad associato, oppure licenziarmi. I criteri sono chiari fin da subito, e sono verificati ogni anno: avere un certo numero di pubblicazioni l’anno, sottoporre richieste di fondi all’NSF (National Science Foundation) e ad altri istituti, ricevere buone valutazioni da parte degli studenti ed essere relatore di due o più dottorandi.
Tra il personale ancora in tenure track sono tipiche le discussioni sulla difficoltà nel tenere testa a questi obblighi. È un buon metodo di selezione (per l’università, ovviamente), ma sviluppare un tema di ricerca è più difficile che in altre realtà, come tante in Europa,
dove ci sono più garanzie e si può lavorare più serenamente. Negli States, inoltre, la mobilità di lavoro è molto ampia: cambiare lavoro e trasferirsi anche da una costa all’altra ogni cinque-sei anni è normale, benché ponga problemi logistici non da poco e riguardi soprattutto i più giovani. Chi ha appena finito il dottorato e cerca lavoro lo sa: nel gruppo di Ricerca Operativa del mio ex dipartimento a Clemson nessuno ha un PhD conseguito a Clemson e nemmeno in Carolina del sud.
Questa apertura a ricercatori provenienti da altrove sembra però ristretta al nord America. Nella mia breve esperienza ho partecipato alla selezione di candidati per posizioni simili alla mia; molti candidati, spesso validissimi, con un PhD di un’università europea non erano nemmeno considerati. Ovviamente non è la regola, ma il sistema accademico americano è particolare e sembra fidarsi solo dei PhD caserecci, che peraltro hanno più occasioni di mostrarsi fin dal primo anno di studi grazie a conferenze locali e ad altre iniziative.
Una parte importante di questo lavoro è la preparazione di richieste di finanziamento all’NSF e ad altri enti che erogano fondi di ricerca. L’università, che incassa una percentuale cospicua di questi fondi (circa il 33% a Clemson), organizza corsi su come scrivere una richiesta e incoraggia il personale docente affinché scriva diverse proposte ogni anno. I vantaggi per il ricercatore di una richiesta andata a buon fine sono un mese di stipendio (la maggior parte dei professori USA è pagata nove mesi l’anno), fondi per viaggi a conferenze e materiali di studio e uno o più anni di stipendio ai suoi dottorandi. La competizione è feroce, quindi spesso si scrive una richiesta pur sapendo che le chances di ottenere i fondi sono scarse.
Per il resto, il mondo accademico degli States non è poi molto diverso da quello europeo: ci si deve giostrare tra studenti, collaborazioni, doveri amministrativi e ricerca vera e propria. Questo però non significa che trasferirsi oltreoceano non abbia dato frutti, anzi. Non posso essere imparziale, ma oltre ad aver acquisito maggiore visibilità, data dall’avere una rete di conoscenze nei due ambienti americano ed europeo, ho potuto cominciare collaborazioni a lungo termine con diversi ricercatori che lavorano negli USA, vivere in posti molto particolari (il profondo sud-est, credetemi, ha un fascino speciale) e vedere la realtà accademica europea con occhi diversi.
L’industria: il mondo di Xpress
Mi sono trasferito nell’industria per molti motivi, e solo in parte professionali. Il trasferimento non ha portato grossi cambiamenti: riesco a fare molta ricerca anche nella mia posizione attuale, posso pubblicare articoli, sono associate editor di due riviste e partecipo a due/tre conferenza o workshop l’anno. Il software che sviluppiamo dipende moltissimo dai risultati della ricerca sull’ottimizzazione intera e nonlineare, quindi dobbiamo essere sempre aggiornati su quanto succede nel mondo accademico.
Se da un lato non ho più studenti da seguire e corsi da tenere, dall’altro ci sono standard di produzione e scadenze da rispettare. Il lavoro di implementazione di un team di una mezza dozzina di persone è molto interessante e ci impegna in lunghe discussioni di ricerca davanti alla lavagna. Implementare un risultato teorico recente in un software commerciale di ottimizzazione è molto più difficile di quanto sembri, sia per la dimensione del software sia per il numero di persone che l’ha sviluppato e per la sua età (la prima versione è uscita più di vent’anni fa).
Posso dirmi fortunato sotto molti aspetti: oltre ad aver lavorato in ottime università, nonostante il passaggio all’industria ho mantenuto il contatto con il mondo accademico e la ricerca. Credo che per chiunque abbia la ricerca nel cuore sia difficile trovare nell’industria un lavoro altrettanto stimolante e con le stesse soddisfazioni.
Pietro Belotti