La comunicazione e la divulgazione della matematica hanno un ruolo sempre più importante per la nostra disciplina. E allora, come promuovere attività di comunicazione e di divulgazione, come consolidare la cultura della divulgazione, come formare i futuri divulgatori alla professione del divulgatore e i futuri matematici alla comunicazione? Su queste e altre domande vorrebbe provare a rispondere, o almeno ad aprire il dibattito, Daniele Gouthier. Sarebbe utile ricevere le vostre opinioni in proposito.
Nello scorso mese di marzo, sul Notiziario dell’Umi, è apparsa una mia lettera aperta ai candidati alla presidenza dell’Unione Matematica Italiana “Sulla ricerca e sulla formazione in comunicazione della matematica” nella quale schematizzando dico che negli ultimi decenni le connessioni tra la matematica e il resto della società si sono strette sempre più; la comunicazione ha preso forme variegate, agite da una parte da accademici che si sono messi in gioco in prima persona e dall’altra da professionisti che lavorano in contesti anche molto diversi tra loro. In mezzo, in un continuum non facilmente segmentabile, ci sono dilettanti e curiosi che dicono la loro.
Ricordo che c’è un’essenziale distinzione tra divulgazione e comunicazione: la condivisione del pensiero matematico e le azioni (professionali, culturali o di intrattenimento) che coinvolgono contenuti matematici vedono la partecipazione di individui e gruppi diversi. Alcuni agiscono con consapevolezza, altri meno, in una gradazione che va dal “matematico” al “cittadino comune”. Gli uni e gli altri hanno un ruolo nella comunicazione e la ricerca in comunicazione della matematica è l’insieme degli studi e delle riflessioni su come questa comunicazione avvenga o potrebbe avvenire, quanto sia efficace, quali dinamiche segua, se abbia obiettivi (dichiarati o realistici che siano) o finalità (esplicite o meno). E sostengo, con l’invito di aprire un percorso condiviso di riflessione in merito, che nel nostro Paese manchino (o almeno siano carenti) le sedi per la ricerca e la formazione in comunicazione della matematica. Sul Notiziario di aprile, sia Marco Andreatta sia Barbara Nelli, a quella data entrambi candidati alla Presidenza, hanno dato le loro risposte con denominatore comune la consapevolezza che sulla comunicazione della matematica è importante aprire un dibattito ampio. Oggi, a urne chiuse (e nel frattempo è Marco Andreatta a essere stato eletto presidente), rilancio il dialogo nella speranza che possa allargarsi a chi su MaddMaths! scrive, o legge, e quindi ha un non trascurabile interesse per il tema.
Se assumiamo l’importanza della ricerca e della formazione in comunicazione della matematica, è sicuramente un buon primo passo quello di disegnare una mappa della divulgazione e della comunicazione della matematica esistenti in Italia. Per farlo, è necessario abbandonare il modello “accademico-centrico” e dare giusta rappresentazione alle altre forme di comunicazione, dal momento che il mondo della comunicazione e quello della divulgazione oggi stanno diversificando notevolmente le loro forme espressive: nuove generazioni, ma anche nuovi costumi, agiscono la comunicazione in forme nuove e cercano forme nuove di divulgazione da fruire.
Anche per questo, dobbiamo capire come promuovere attività di comunicazione e di divulgazione; come consolidare la cultura della divulgazione, che non è matematica di serie B ma viceversa è strategica per il buon vivere civile e culturale; come formare i futuri divulgatori alla professione del divulgatore e i futuri matematici (qualsiasi professione vadano in futuro a svolgere) alla comunicazione e al suo ruolo nello sviluppo della nostra disciplina.
Serve creare uno spazio pubblico di visibilità culturale e sociale per la matematica, connettendola al resto della cultura – ma anche ai decisori sociali in senso più largo – del nostro Paese, a partire dai temi di attualità che richiedono la matematica per essere compresi o gestiti. Quanto i matematici sono consapevoli che questa connessione e questo spazio pubblico sono cruciali da un lato per la matematica e dall’altro per il Paese? A volte ho il timore che nella comunità matematica ci sia la convinzione di “bastare a se stessa”, di autogiustificarsi senza bisogno di stimoli e relazioni esterne. Poi mi imbatto in podcast come Il cuore matematico di Enrico Schlitzer, prodotto da MaddMaths!, e tanto la storia che racconta quanto il podcast in sé mi fanno dire che iniziamo a intravedere l’importanza di scambi proficui tra la matematica e il resto della società. E questo mi fa tornare alla ragione principale della mia lettera aperta: la necessità di formare i futuri matematici, con corsi di comunicazione, trasversali a tutte le scienze e interdisciplinari, che facciano parte del curriculum di studio di ogni studente o dottorando in matematica, e la necessità di studi rigorosi che permettano di capire meglio come la matematica comunichi con il resto della società, come si sviluppi e come contribuisca allo sviluppo della società, quali siano la sua efficacia e le sue ricadute, nelle applicazioni e nella cultura.
Senza una ricerca istituzionalizzata – che sicuramente deve collocarsi nel più ampio bacino della comunicazione della scienza – tutto questo è più arduo. E una ricerca in comunicazione della matematica non può non soffermarsi su alcune peculiarità che la distinguono da quella in comunicazione della scienza. La percezione pubblica della nostra disciplina deve fare i conti con un’accettazione sociale della matematica molto più bassa di quella per altre discipline scientifiche. La questione dell’astrazione – a partire dalla stessa numeracy, per la quale potremmo tentare una traduzione quale “livello di competenza nella gestione di fatti numerici elementari” – è critica per gran parte dei nostri concittadini. Il tema dell’utilità (“a che cosa serve la matematica?”) è spia di un’incomprensione profonda che distingue la matematica dalle scienze naturali. Nell’immaginario, la matematica ha una connotazione forte caratterizzata da stereotipi marcati, negativi o “talmente positivi” da essere a tutti gli effetti una presa di distanza. Le sfide dei lavori del futuro – anche oltre il momento di grane esposizione dell’Intelligenza Artificiale nel quale ci troviamo ora – chiamano in causa la matematica in modo particolare. Se le ricadute sociali e le applicazioni delle scienze e della matematica sono, in un certo senso, confrontabili, d’altra parte la matematica, e il suo interagire con il resto della società, ha caratteri specifici: la scienza gode di un’accettazione sociale maggiore, mentre la nostra disciplina è molto polarizzante e ha alti livelli di ostilità; mentre la scienza, agli occhi del cittadino comune, diventa tecnologia e medicina, la matematica ha una dimensione culturale che la tiene lontana dai più. Aggiungiamoci che mentre le indicazioni ministeriali per l’insegnamento inglobano la meccanica quantistica e la teoria dell’evoluzione, accogliendo nella pratica didattica momenti importanti del pensiero scientifico del Ventesimo secolo, la matematica che si incontra a scuola è quella di duecento anni fa, escludendo quindi la massima parte di quello che la ricerca matematica ha fatto nel corso della storia. C’è quindi bisogno di un’attenzione specifica alla comunicazione della matematica nella cornice più ampia di quella della scienza. Allo stesso modo sono convinto che una divulgazione appassionata e ben intenzionata non sia sufficiente. Serve una riflessione che comprenda le mille altre forme di comunicazione della matematica e che apra concretamente alla formazione e alla ricerca. Ritengo che oggi sia importante parlarne a cominciare da un confronto “sulle colonne di MaddMaths!” tra quanti praticano diverse forme di comunicazione o portano avanti una propria riflessione in un’ottica di ricerca e comprensione di come la matematica comunica.
Daniele Gouthier
Hanno risposto a questo articolo:
Nicola Ciccoli: Comunicare come, 3 luglio 2024
Domingo Paola: Educazione matematica e comunicazione, 6 luglio 2024
Marco Menale: Comunicazione della matematica: valorizzazione e università, 17 luglio 2024
Simone Ramello, Comunicazione della matematica: il punto dall’estero, 23 luglio 2024
Immagine di copertina: Immagine di freepik




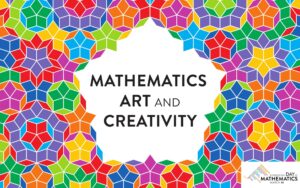

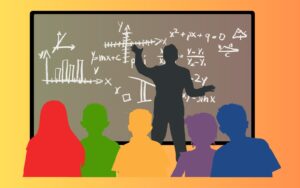

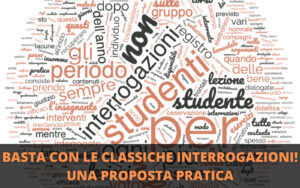





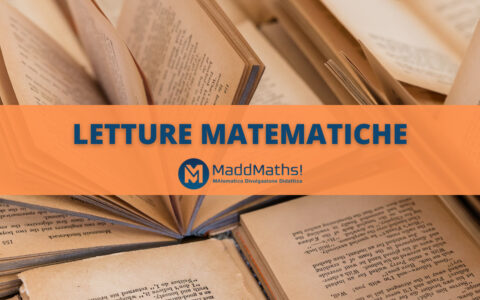
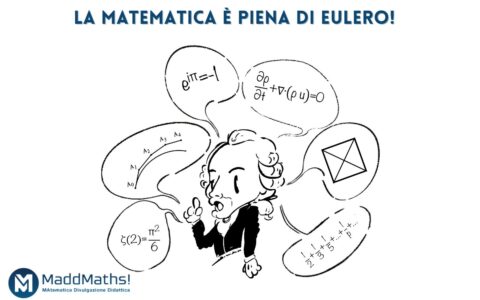



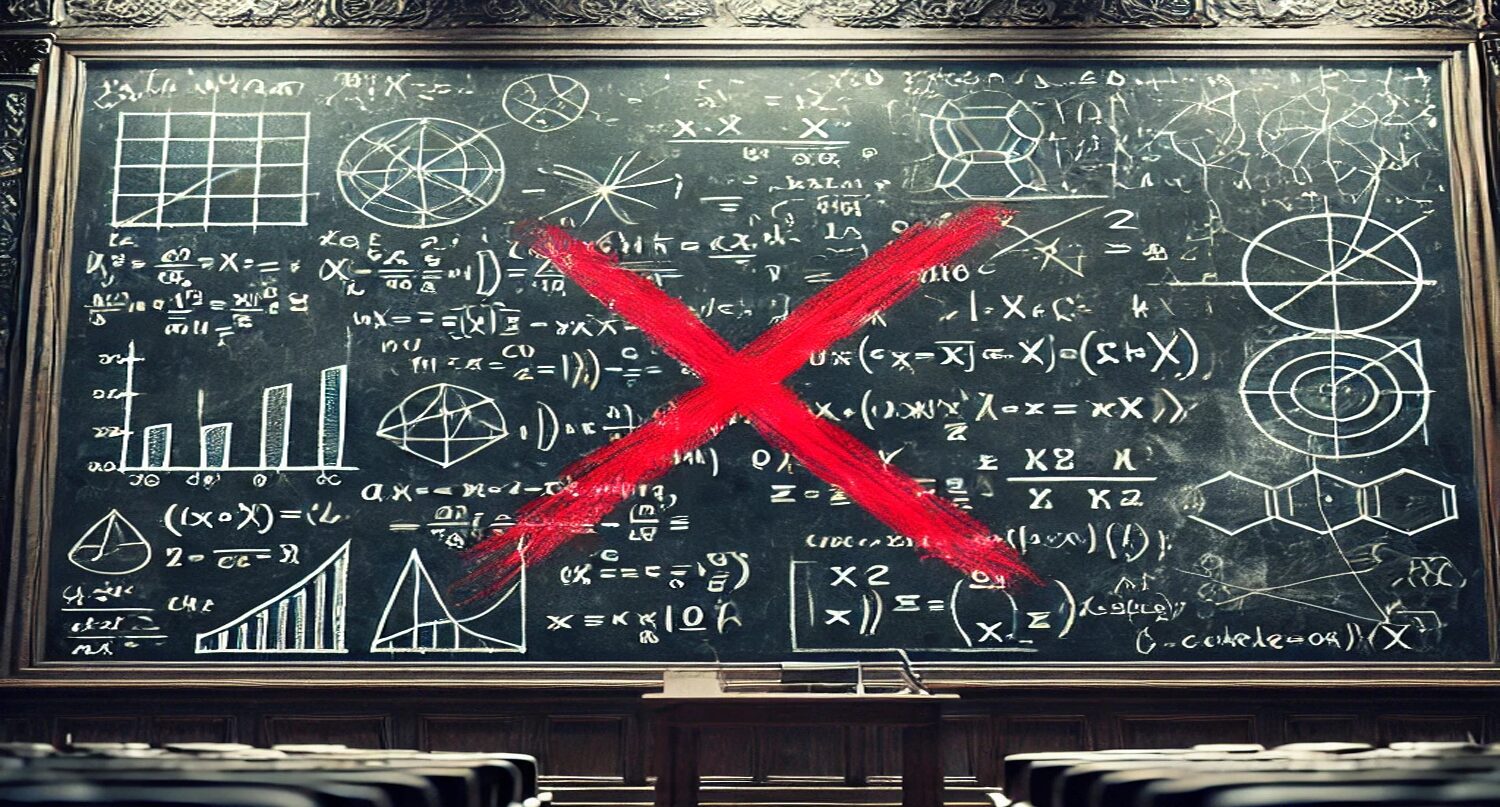
Trackback/Pingback