Maurizio Codogno, meglio noto in rete come .mau., racconta come lui vede la matematica, con la scusa di non doverla insegnare né crearne di nuova. Il tema di oggi è il testo della maturità scientifica 2025, o meglio quello che gli è piaciuto oppure non ha apprezzato per nulla.
Lo so, non bisogna dire “maturità” ma “esame di Stato” (“conclusivo del secondo ciclo di istruzione”, se volete fare le cose in grande). Ma io sono un boomer, e per me si parla di maturità, punto. So anche che l’esame è stato fatto tre settimane fa, e chiunque avesse voluto sapere le risposte le avrà già trovate, per esempio partendo da studenti.it (il primo sito che ho trovato). Ma a me interessa come al solito vedere le cose in modo un po’ diverso, e quindi mi soffermerò su alcuni punti che non hanno a che fare con la risoluzione di problemi e quesiti. Per la cronaca, le tracce ufficiali sono pubblicate sul sito del ministero, potete guardarle tranquillamente da lì.
Cominciamo con il profluvio di citazioni. Posso accettare quella ciceroniana, perché parla del gioco con i dadi su cui si basa il problema. Ma le altre tre, quelle in esergo sui problemi e l’ultima in fondo ai quesiti, sono inutili e dannose. Dannose perché potrebbero trarre in inganno il giovane maturando, che si trova scritto «La ragione non è nulla senza l’immaginazione» e si chiede cosa diavolo debba immaginare; o peggio ancora perché la frase attribuita a Platone (da chi, non si sa) «La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l’infinito» potrebbe far pensare a qualcosa che ha a che fare con l’infinito per risolvere il problema. Ma come dicevo, quelle citazioni erano inutili: gli studenti erano giustamente così stressati dal dover svolgere il compito che non avranno nemmeno letto le citazioni. Poi ho dei forti dubbi che Hilbert abbia davvero detto «La matematica non conosce razze o confini geografici; per la matematica, il mondo culturale è una singola nazione»: il mio tedesco non è certo il massimo, ma non ho visto nulla del genere nelle mie ricerche. Su Cartesio, la citazione potrebbe essere tratta molto liberamente dalle Cogitationes Privatae del 1619, dove scrisse «Ratio est quod poetae per enthusiasmum et vim imaginationis scripsere». Taciamo per carità di patria.
Sui problemi non ho molto da dire; per quanto riguarda gli esercizi, devo invece segnalare con piacere alcuni di essi, nonostante le voci negative che ho letto in giro. Ho già accennato al colpo di Venere: il quesito è una semplice applicazione delle leggi della probabilità, ma credo che sia importante vedere come il gioco di azzardo generava discussioni già un millennio e mezzo abbondante prima che Fermat e Pascal cominciassero a vedere se la matematica poteva essere utile per dare una risposta più o meno definitiva ai giocatori incalliti. Anche l’ultimo quesito, sugli anagrammi, è abbastanza standard per chi ha fatto combinatoria ma richiede comunque un certo colpo d’occhio. Mi spiace solo che gli estensori della prova di esame non abbiano pensato a mettere la citazione dal Pendolo di Foucault, dove Umberto Eco inserisce un programma per calcolare gli anagrammi del tetragramma IHVH, sbagliandolo (perché in questo tetragramma ci sono due lettere uguali: è lo stesso caso di VACANZA nel quesito).
Infine il problema con “i venti centesimi” (l’opera “Forme uniche della continuità nello spazio”) ha un punto che non mi pare essere stato colto. Dal mio punto di vista è irrilevante il fatto che Boccioni non abbia certo pensato alle due funzioni indicate nel quesito. Quello che mi è piaciuto è che per vedere la similitudine tra la teoria e la pratica occorra ruotare l’opera, o se preferite scegliere “un opportuno sistema di riferimento” come scritto nel testo. Di solito le funzioni sono valutate sul solito sistema di assi cartesiani con la x sulle ascisse e la y sulle ordinate, mentre qua dobbiamo ruotare gli assi. Non sembra, ma questo cambio di sistema di riferimento apre nuovi orizzonti, perché ci costringe a non pensare in maniera ordinata e meccanica.
In definitiva? Un compito senza infamia e senza lode. Ma del resto una prova di esame serve a valutare se e quanto gli studenti hanno compreso il programma, non a mostrare la bravura degli esaminatori!
Guarda la pagina di questa rubrica






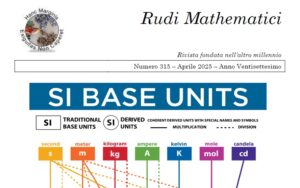

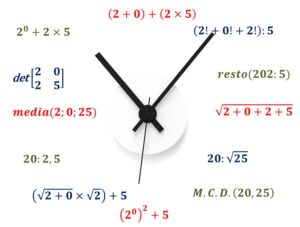
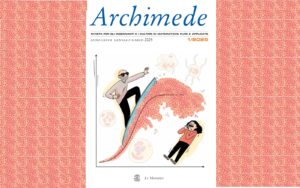

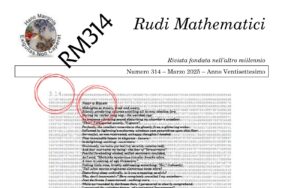



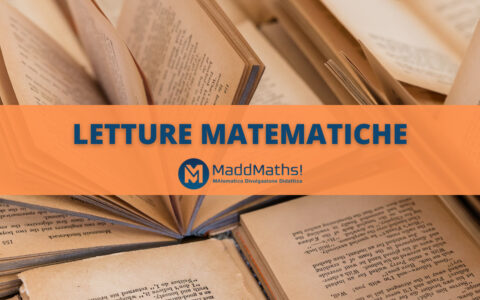
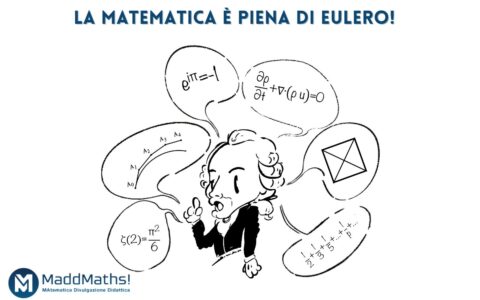

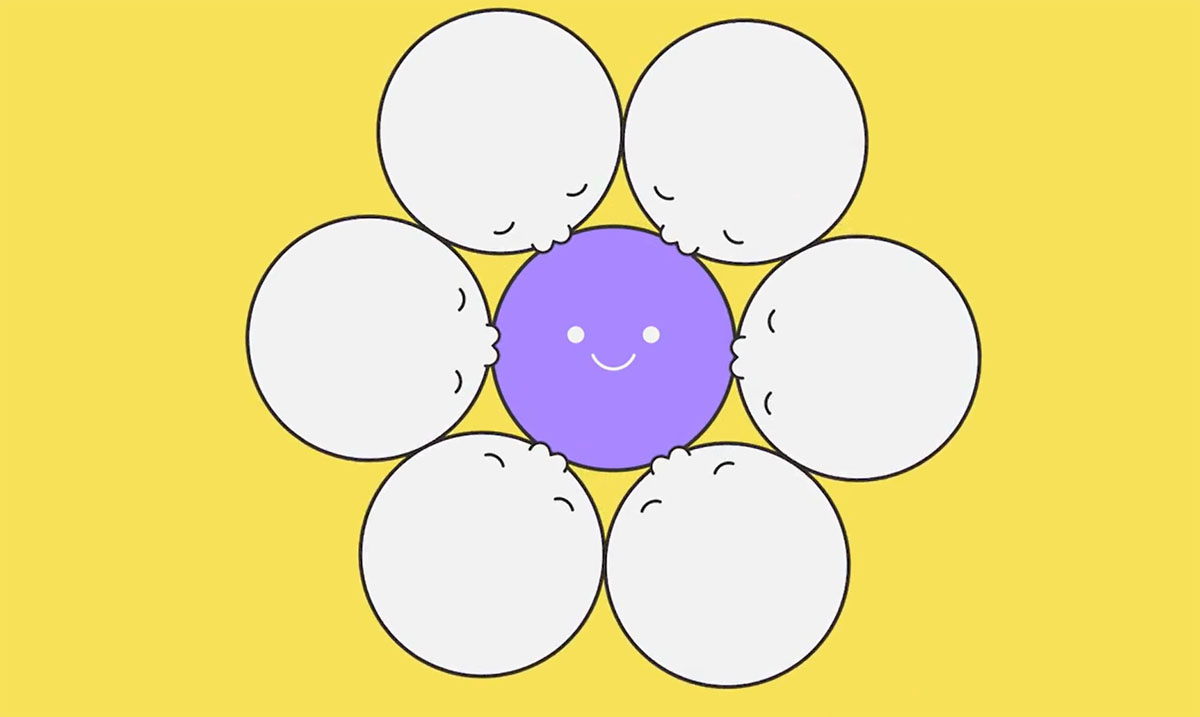




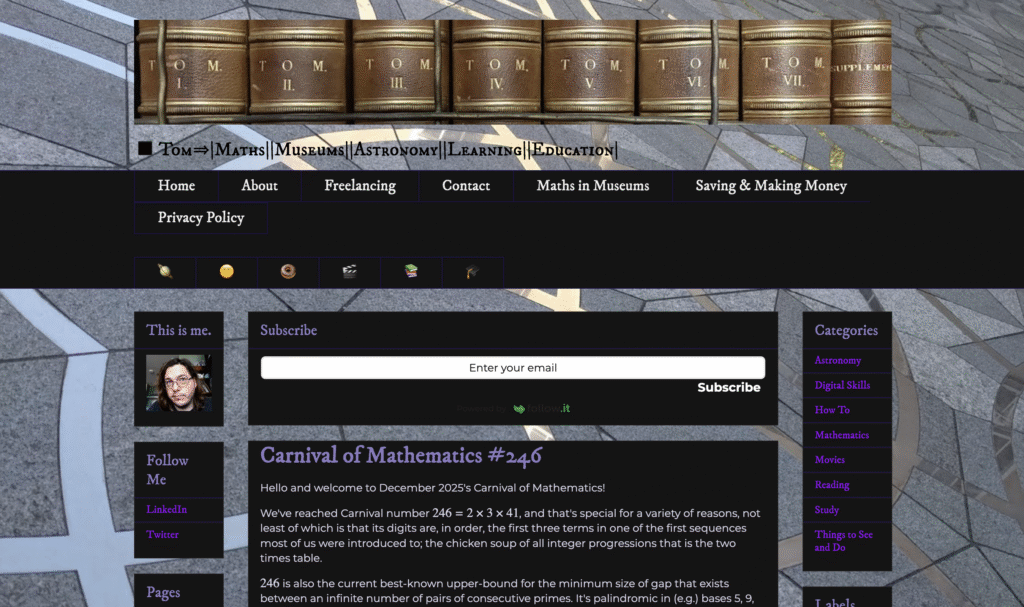

Trackback/Pingback