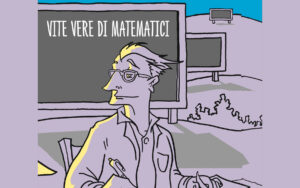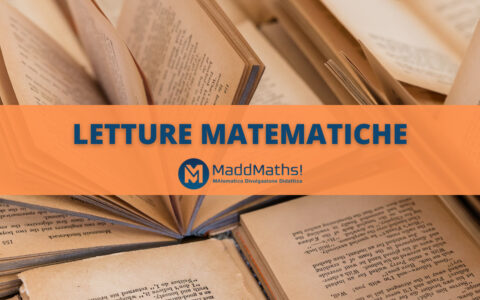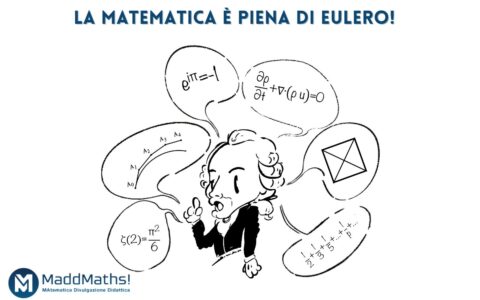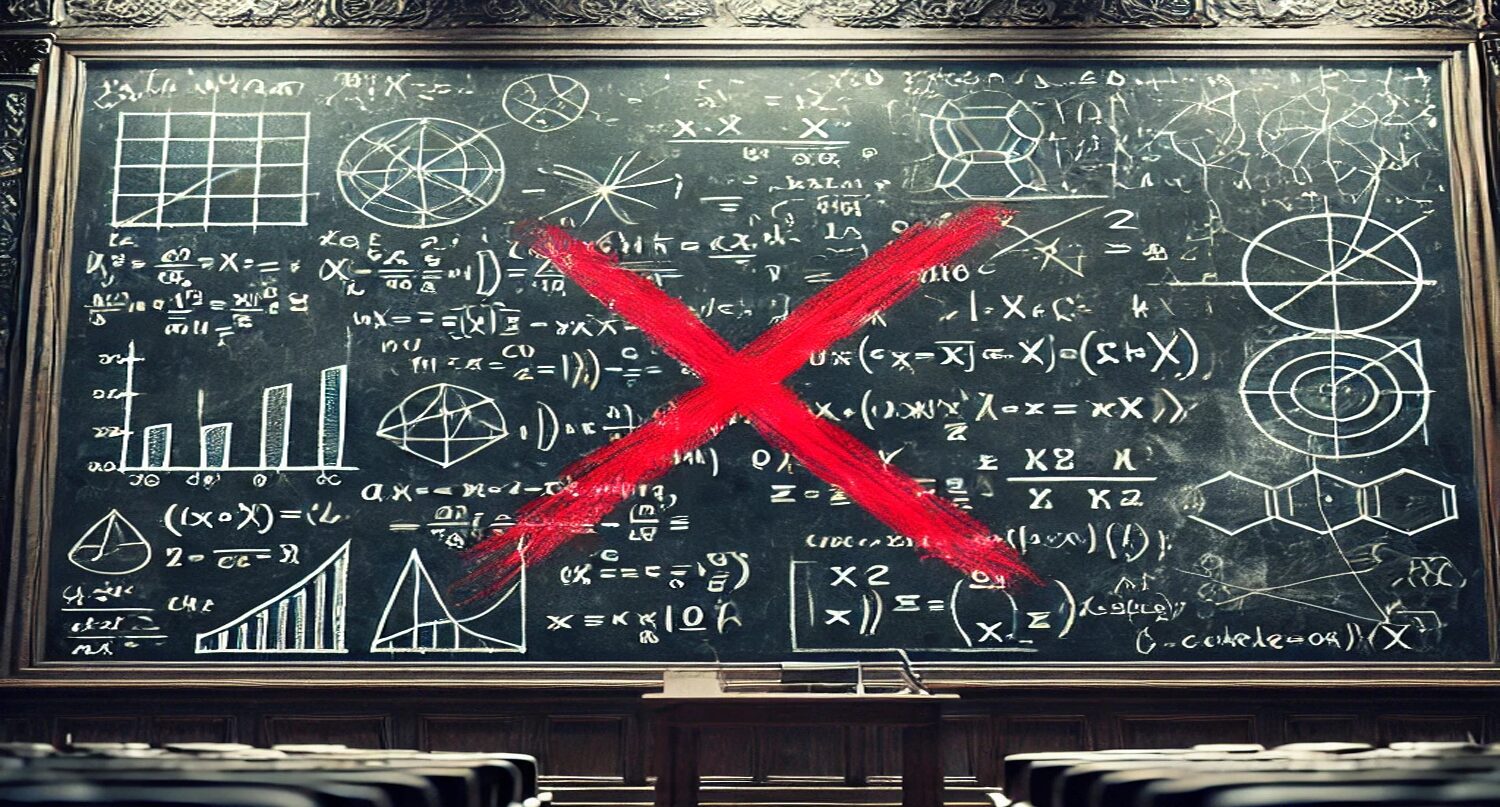Storie che contano è un progetto per esplorare la matematica e le sue tantissime branche con una lente diversa: quella della scrittura. Il testo di Valentina Penza prende spunto da una delle più famosi costanti matematiche. Buona lettura!
Valentina Penza, “π”
Questa faccenda dei numeri irrazionali e trascendenti a Claudio non andava proprio giù.
Era bravo in matematica, lo era sempre stato. Tutti i suoi maestri e professori, da quando aveva iniziato ad andare a scuola, non facevano che ripetere ai suoi genitori che era “portato”, qualsiasi cosa questo significasse.
In realtà non è che a lui sembrava di essere portato da qualcosa o per qualcosa, sapeva però quanto si divertisse a svolgere quegli esercizi e risolvere quei problemi sui quali vedeva i suoi compagni disperarsi, annaspare con lo sguardo perso nel vuoto, come qualcuno a cui si cercasse di comunicare parlando in un idioma completamente estraneo. Sì, lui si divertiva a risolvere equazioni, a ridurre espressioni, individuare quale fosse la quantità più comoda da usare come incognita per risolvere un problema anche intricato. Anzi più era intricato, più la questione diventava intrigante e più si divertiva.
Ma quella faccenda là, quella delle cifre che si susseguono all’infinito, ma soprattutto in maniera impredicibile se non aspettando il risultato dei vari algoritmi, no, quella non gli andava proprio giù. Non era il concetto di infinito in sé il problema; a quello si era abituato facilmente: i numeri naturali sono infiniti, ma la cosa non lo aveva mai turbato, perché se pensava a un numero, sapeva esattamente quale sarebbe venuto dopo. Anche i numeri periodici gli stavano simpatici, soprattutto quelli risultanti da una divisione il cui algoritmo impiegava un po’ a far intravedere la periodicità… No, niente calcolatrice o computer per Claudio: a lui piaceva risolvere le operazioni da solo, passaggio per passaggio, pure delle “semplici” divisioni. Anche in quel caso le cifre sarebbero proseguite all’infinito, ma quello non lo turbava… 1253:900=1,265656565… Ecco, quello non era un problema; poteva prendere le cifre che voleva, fermandosi all’approssimazione che voleva, e poi se avesse avuto voglia di avere un decimale in più avrebbe saputo subito dire quale cifra ci sarebbe stata.
Bello, semplice, regolare. Tutto sotto controllo.
Invece tutti i suoi professori avevano sempre insistito a dirgli che il rapporto tra una circonferenza e il suo diametro era un numero con infinite cifre decimali e che l’alternanza di queste cifre era priva di regolarità alcuna. Non gli sembrava possibile, così come quella storia che qualsiasi sequenza di cifre gli venisse in mente, per esempio la sua data di nascita, la quantità di soldi sul conto corrente dei suoi genitori, il numero di telefono di quella ragazzina della sezione accanto che gli piaceva tanto… Beh, tutte, prima o poi, ad avere abbastanza tempo e pazienza di cercarle, si sarebbero ritrovate al suo interno.
No, non poteva essere così. Qualcosa doveva potersi capire in quella sequenza di cifre, qualcosa che desse un senso al suo dipanarsi di fronte a sé:
3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679…
A dodici anni aveva già memorizzato le prime cento cifre, a sedici aveva letteralmente coperto le pareti della sua stanza con circa due milioni di cifre. Quando di anni ne aveva quasi trentacinque, una laurea e un dottorato alle spalle, era oramai un matematico abbastanza conosciuto nell’ambiente, si era dedicato a diversi campi della matematica e dato contributi importanti. Eppure nella sua stanza era rimasto, abbastanza nascosto alla vista dei curiosi, un computer collegato alla rete dell’università per sfruttare nelle ore notturne la potenza di calcolo senza essere troppo di impiccio, e sul quale aveva implementato un programma basato sulla formula di Chudnovsky, con diversi miglioramenti e aggiustamenti per aumentarne la velocità di convergenza. Quel programma girava ininterrottamente da dieci anni e macinava ogni notte centinaia di cifre in più. Sicuramente aveva superato il record riportato negli annali dei milioni di trilioni di cifre conosciute. A Claudio non importava che gli altri sapessero. Era lui stesso che doveva sapere e capire.
Non appena aveva un po’ di tempo, guardava queste cifre e le analizzava personalmente – sempre un po’ di nascosto dai suoi colleghi per paura di essere preso in giro- continuando a cercarvi un significato profondo, un disegno, un principio ultimo, qualcosa che il suo analizzatore automatico non avesse colto. C’era, in particolar modo, qualcosa che continuava a disturbarlo, un residuo dell’incredulità che aveva provato a dodici anni: il suo computer avrebbe continuato indefessamente a tirare fuori cifre, senza porsi troppi problemi, ma senza uno schema sottostante, senza qualcosa che, a un certo punto, fornisse una regola che consentisse, anche una volta interrotto l’algoritmo, di sapere quale fosse la cifra successiva; l’universo stesso sarebbe potuto finire senza che nessuno avesse mai saputo realmente quanto valesse quel rapporto là. Un cerchio – facilmente costruibile con una corda e un bastoncino – e il suo diametro, anch’esso ben visualizzabile semplicemente raddoppiando quella stessa corda: il mondo era pieno di quegli oggetti là. Eppure l’universo sarebbe finito prima di sapere, prima di conoscere. L’universo non avrebbe mai saputo quale sarebbe stata la cifra seguente a quella che era stata calcolata da un qualsiasi computer (ammesso ne sarebbero mai potuti esistere) subito prima dell’ultimo collasso o subito prima che anche l’ultimo buco nero fosse evaporato.
Passarono altri dieci anni, e il tempo da dedicare a quell’analisi si era ridotto sempre di più, anche perché intanto aveva implementato un programma che avrebbe sperabilmente saputo cercare regolarità in maniera automatica molto meglio di quanto avrebbe potuto fare lui stesso di persona.
Ogni tanto guardava gli output dell’elaboratore intelligente, ma non c’era mai nulla di interessante. E questo lo sapeva anche prima di controllare, perché aveva impostato un “alert” sul programma affinché gli mandasse un segnale vibrante sul suo orologio.
E lui quell’orologio lo aveva sempre con sé.
E quell’orologio non aveva mai vibrato.
Fino a oggi.
Stava tenendo una lezione; era molto bravo come docente e di solito si fermava con piacere alla fine di ogni lezione per rispondere alle domande dei suoi studenti. Ma questa volta, nel mezzo di una dimostrazione, smise improvvisamente di parlare, le gambe cedettero per un secondo di troppo e lo costrinsero a sedersi. Il suo braccio tremava, ma solo in parte a causa della vibrazione dell’orologio. Si alzò improvvisamente, così come improvvisamente si era interrotto, congedò velocemente i suoi studenti, e corse come mai pensava sarebbe stato in grado di correre verso il suo studio.
Il tremore non lo aveva mai lasciato.
Guardò lo schermo e lo vide. Vide lo schema, ne capì quasi immediatamente il senso: dopo trilioni di trilioni di cifre era lì davanti a lui.
La fine del pi greco, o almeno della sua aleatorietà, e la conferma di quello che aveva sempre pensato: l’Universo sapeva. E nello stesso istante in cui vide lo schema, capì e seppe anche lui – con estrema precisione – quando sarebbe stato il momento ultimo di quell’Universo e la fine di tutto.
Note
- L’algoritmo di Chudnovsky (https://observablehq.com/@galopin/the-chudnovsky-algorithm-for-calculating-pi) è uno dei metodi più veloci per il calcolo delle cifre decimali di pi greco e si basa sulla rapida convergenza di una serie ipergeometrica generalizzata.
L’autrice
 Valentina Penza è nata a Roma nel 1973. Laureata in Fisica e con un dottorato in Astronomia, è docente di scuola secondaria e collaboratrice con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata.
Valentina Penza è nata a Roma nel 1973. Laureata in Fisica e con un dottorato in Astronomia, è docente di scuola secondaria e collaboratrice con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata.
Il racconto è scaricabile qui nei formati PDF, ePub e AZW3.
Anche tu scrivi racconti matematici? Clicca qui!
Per maggiori informazioni, contattare Alice Raffaele, curatrice della raccolta.