I criteri di Bradoford Hill sono utilizzati negli studi statistici randomizzati per riconoscere rapporti di causalità tra grandezze. Perché correlazione non è causalità. Ce ne parla Marco Menale.
Nel mio gruppo di ricerca ci lamentiamo dei ricorrenti mal di schiena. Più intenso è il periodo di studio su un problema, peggiori sono gli effetti. Ma allora: è la fisica-matematica a causare i mal di schiena? Certo che no, perché correlazione non è causalità. I due fenomeni sono correlati, ma a metterli assieme è un terzo: le tante ore al computer con postura errata. Come evitare di concludere causalità dove c’è solo un rapporto di correlazione? Soprattutto, con l’aumento dei dati in rete, a disposizione di tutti gli intenti, e la cattiva statistica, come la chiama Francesca Dominici (qui per l’intervista), fonte di fake-news? Ci sono i criteri di Bradford Hill.
Sir Austin Bradford Hill è stato uno statistico britannico, pioniere degli studi clinici randomizzati, da lui utilizzati in vari contesti. Tra gli altri, due sono particolarmente noti. L’efficacia della streptomicina nella cura della tubercolosi, con la creazione di uno standard per il trattamento. E poi, assieme a Sir William Richard Doll, il fumo come causa del cancro ai polmoni. Con questi e altri studi, ha individuato nove criteri per dedurre rapporti di causalità tra fenomeni osservati, e non confonderli per sole correlazioni. Hill li elenca e li descrive nell’articolo “The environment and disease: association or causation?”, del 1965. Sviluppa questi criteri a partire da problemi di salute pubblica. Per lui rappresentano un test di relazione di causalità tra un’esposizione e un certo esito. Un esempio di esposizione è il fumo, con esito il cancro ai polmoni. Semplificando, l’esposizione rappresenta la causa, mentre l’esito l’effetto.
Da quel momento, sono stati ampiamente utilizzati per verificare rapporti di causalità negli studi statistici. E anche per smascherare semplici (e sole) correlazioni. Tuttavia, si è generato dibattito nella comunità scientifica, così da modificarli nel corso del tempo, con l’avanzare delle conoscenze. Qui proponiamo la versione più recente (rispetto a quella di Hill) del 2009, contenuta nell’articolo “The evolution of evidence hierarchies: what can Bradford Hill’s guidelines for causation’ contribute?”, di J. Howick, P. Glasziou e J.K. Aronson.
I tre scienziati dividono i criteri, per dedurre rapporti di causalità tra un’esposizione (causa) e un esito (effetto), in tre categorie di evidenze.
Dirette:
- La dimensione dell’effetto non è attribuibile a fattori confondenti.
- C’è un’appropriata vicinanza temporale e/o spaziale. Ossia, la causa precede l’effetto, che si verifica in un certo intervallo di tempo. Eventualmente, anche allo stesso istante.
- L’effetto aumenta (vs. diminuisce) all’aumentare (vs. al diminuire) dell’esposizione.
Meccanicistiche:
- Esiste un possibile meccanismo d’azione a spiegare la causalità; ad esempio, una reazione chimica conosciuta.
Parallele:
- L’effetto è in accordo a quanto già conosciuto.
- Lo studio è replicabile.
- In studi simili si riscontra lo stesso effetto.
Si è passati da nove criteri a sette evidenze.
Il dibattito continua, perché definire precisamente cosa sia un rapporto di causalità è un problema ancora aperto. Tuttavia, questi criteri forniscono un ulteriore supporto alla statistica per gli studi randomizzati. E più in generale per non giungere a rapide conclusioni, a partire da un set di dati. Le applicazioni vanno oltre la medicina. È il caso della scienza forense. La statistica è entrata nei tribunali. Ad esempio, in alcune cause civili, per verificare il nesso causale tra esposizione ad alcune sostanze e insorgere di patologie nei lavoratori. Oppure, per concludere solo una correlazione. Proprio come tra la fisica-matematica e il mal di schiena.






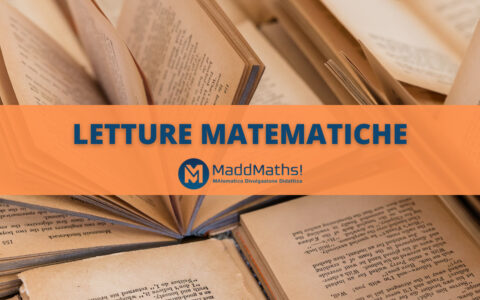


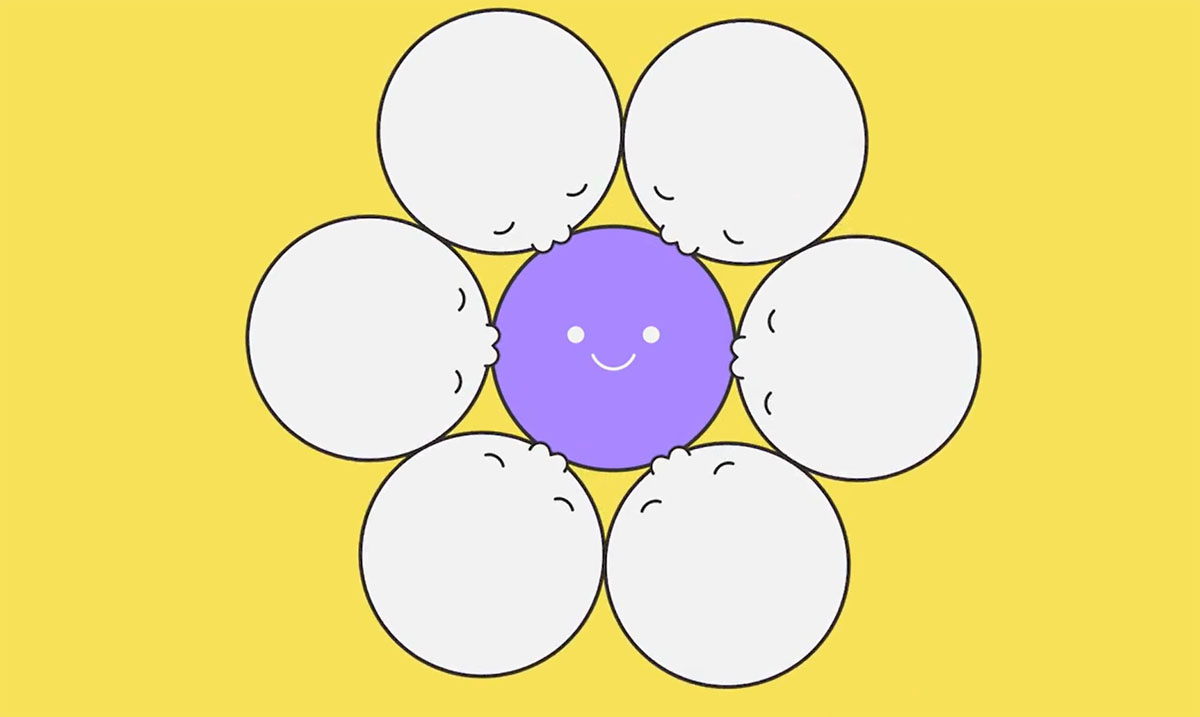




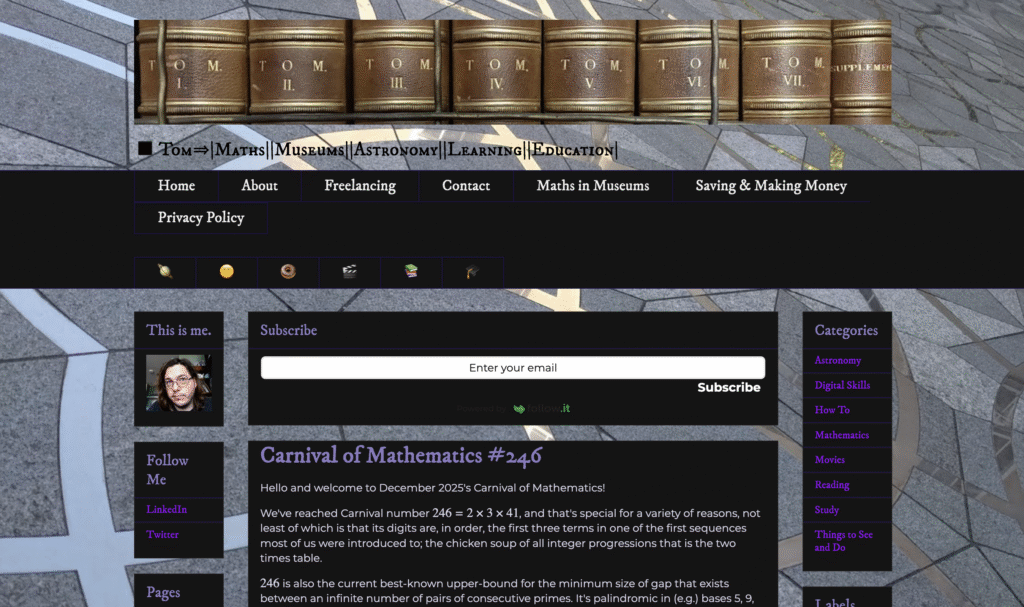

Come medico ne applico alcuni quotidianamente nel risolvere il problema pratico se un sintomo può essere attribuito a un farmaco.