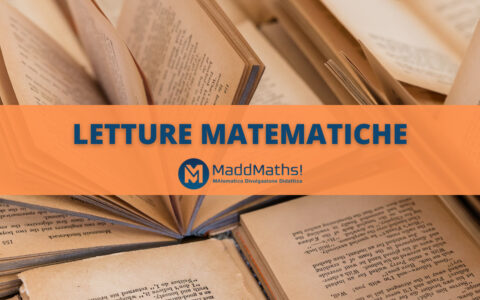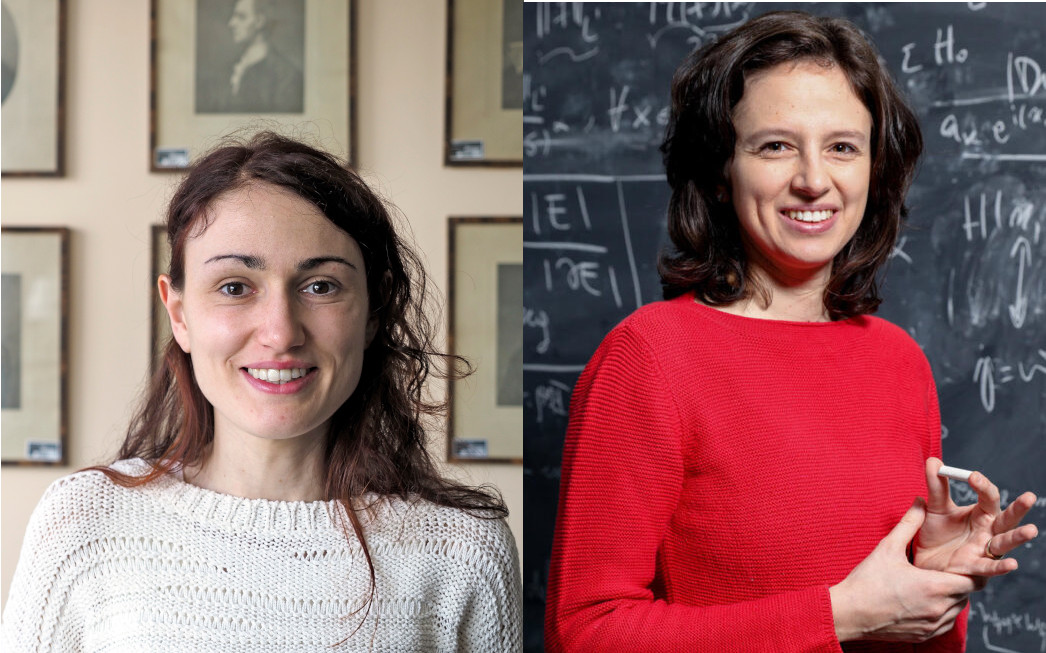Marco di Francesco, matematico dell’Università dell’Aquila, prova a raccontarci cosa ha significato e sta significando il terremoto dell’Abruzzo, non solo per le persone ma anche per l’Università.
Sono le 3.32 di notte e sono in strada, sotto casa. Le crepe sono ben visibili sulle mura esterne, interi blocchi di mattoni sono venuti giù, grazie alla luce d’emergenza delle scale intravedo i tramezzi interni del palazzo, squarciati. Fuori è il buio totale, fa freddo … La mia mente sta realizzando cose che il corpo tremante fatica a metabolizzare.
All’improvviso, nel passaparola confuso, sento che la “casa dello studente” è crollata. Ci sono dei morti. Da quel momento la scossa che mi ha buttato giù dal letto cessa di essere il momento di paura più terribile della mia vita e diventa l’incubo senza fine della mia città colpita a morte, del centro storico devastato. Nei giorni successivi diventerà la tragedia della mia Università: sono 55 gli studenti che hanno perso la vita la notte del terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila. Ne conoscevo solo uno di persona, ma chissà quanti mi erano passati davanti agli orali di analisi, quanti nomi letti nell’elenco delle vittime avrò copiato distrattamente sul file Excel dei compiti scritti, quante facce avrò visto e salutato ogni giorno in facoltà …
…
Sono passati due giorni, mi arriva una email con le foto della mia facoltà, irriconoscibile. Dentro non si può andare, le foto si fermano all’atrio d’ingresso. Le aule non si vedono, ma posso immaginarmele. Mi chiedo se rimetterò mai piede nella A0.1, con la vista sulla piana di Navelli, o nelle aule del primo piano, con il Gran Sasso che si staglia al centro della vetrata. Mi viene in mente la pausa della lezione di “modelli matematici” messa appositamente alle 5 per evitare la folla di studenti alle macchinette del caffè, che ora mi immagino sdraiate sul pavimento. E il mio ufficio? Anche qui posso solo immaginare la libreria addossata alla scrivania da poco riordinata in vista di un lungo periodo di missione. Potrò mai recuperare i miei libri, gli articoli, gli appunti dei corsi seguiti da studente e da dottorando, tutto ciò che ho sentito il bisogno di mettere da parte dei miei primi 5 anni da ricercatore?
…
Sono le due del pomeriggio, non è passata neanche una settimana, all’altro capo del telefono c’è il mio capo. Siamo in fermento per riprendere subito a fare il lavoro che amiamo. C’è da posticipare la nostra scuola estiva, chiamare l’agenzia che ci finanzia e chiedere un rinvio. C’è da riorganizzare la didattica, fare decine di telefonate per cercare disponibilità di aule nei comuni vicini. C’è da coordinare la fase di emergenza del nostro master internazionale. C’è da dare risposte alla dottoranda che lavora sotto la mia supervisione, agli studenti che fanno domande sulla prosecuzione dei corsi, sugli esami. Il mio lavoro, la mia vita di ricercatore e di docente, vissuta nei luoghi dello studio e del sapere, ricomincia così, parlando al telefono con i colleghi a distanza di centinaia di chilometri, nella solitudine del mio computer recuperato con poche altre cose nell’incoscienza della mattina dopo il sisma, travolto dalle email dei colleghi spagnoli, austriaci, tedeschi, francesi, americani.
…
E’ passato un mese e mezzo. L’Università degli studi dell’Aquila, unico vero motore della città, inizia a mettere le prime basi per la ricostruzione. La didattica è ripresa nei comuni vicini e con il supporto di un portale didattico telematico. Il rettorato si è insediato nell’atrio dell’unico edificio rimasto in piedi, quello della Facoltà di Scienze di Coppito. Tante domande sono ancora in attesa di risposta, gli studenti ancora scioccati dal trauma chiedono certezze sugli alloggi, in tutti ci chiediamo dove saremo il prossimo anno accademico. Precarietà e flessibilità sono diventate parole chiave del nostro lavoro. Sembra tutto davvero troppo grande, proprio la stessa sensazione che tutti abbiamo provato la notte del 6 durante quei 25 interminabili secondi: è tutto troppo grande per poter fare qualcosa. Ma torna subito alla mente la sensazione provata non appena la scossa è finita: andiamo, che è finita! Chi ha avuto la fortuna di poter vivere questo momento, il momento della fine della scossa, chi come me ha potuto raggiungere di corsa la porta d’ingresso infilando un paio di ciabatte ed il giaccone scendendo le scale tra i calcinacci, è stato investito da uno slancio improvviso di forza interiore: è finita, usciamo! Torna in mente la stessa frase, contestualizzata alla situazione della nostra università e condita con un po’ di ottimismo quanto mai necessario. Il terremoto è finito, ripartiamo.
Marco di Francesco