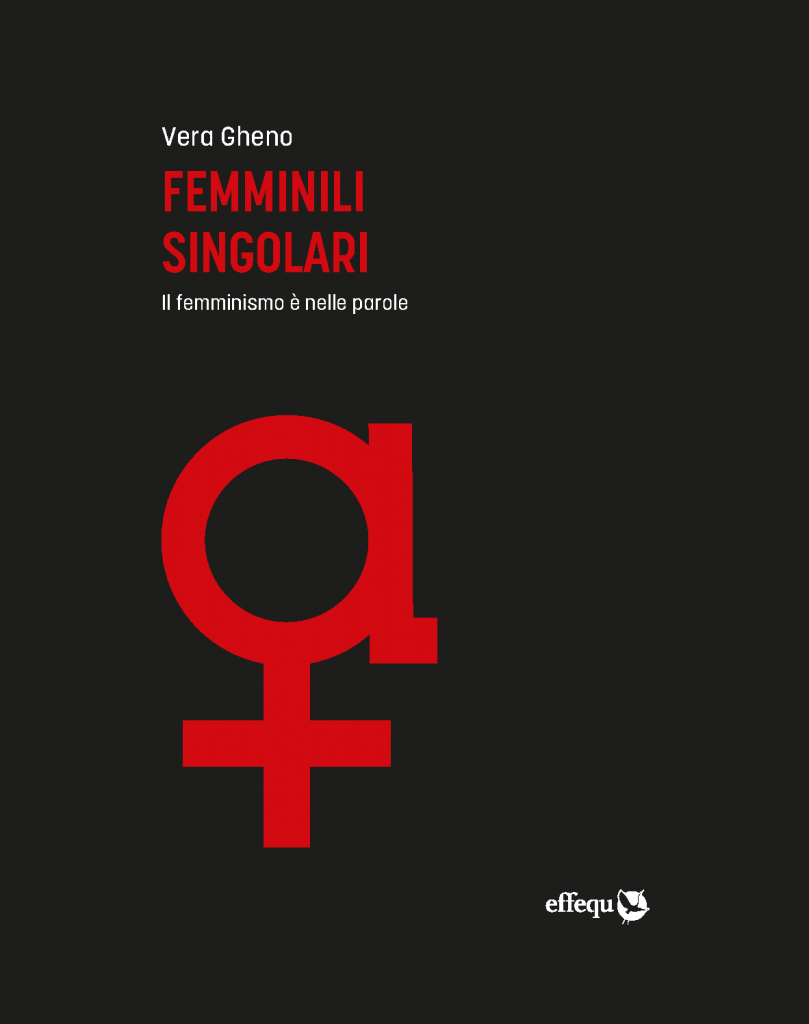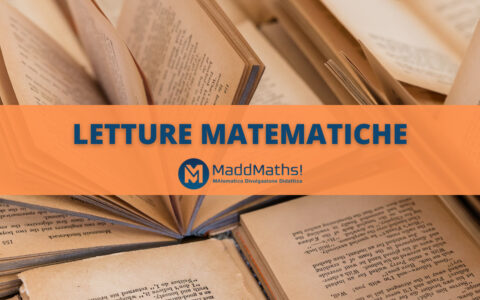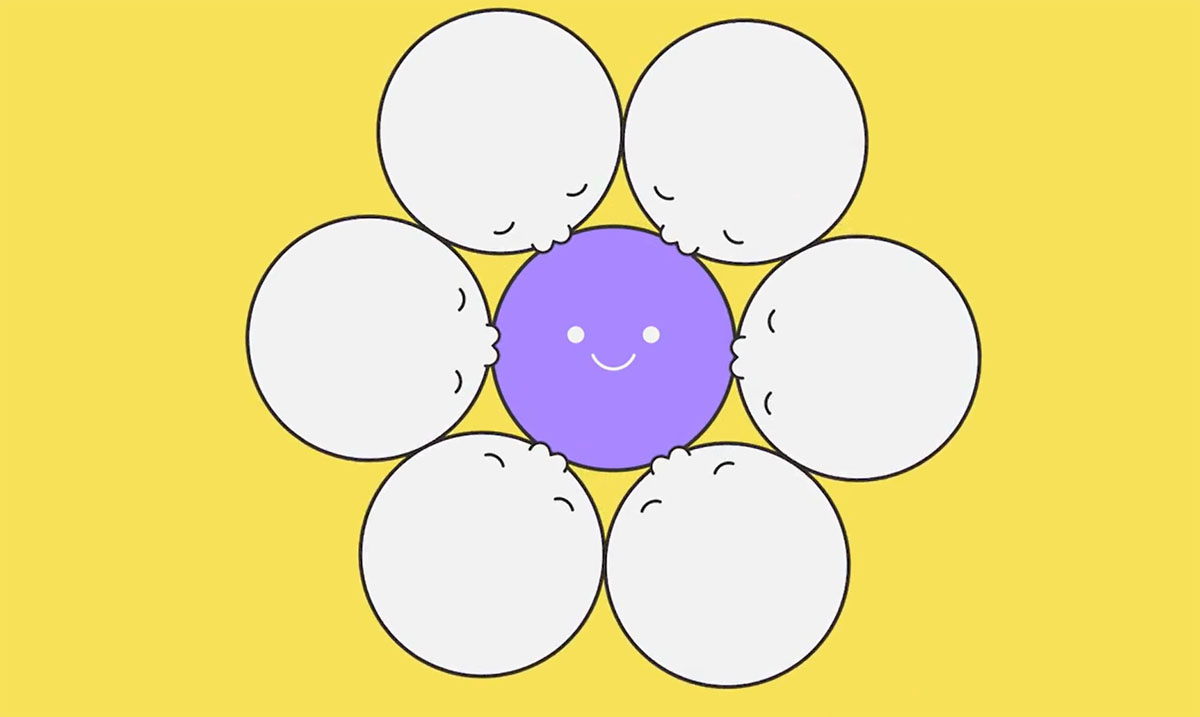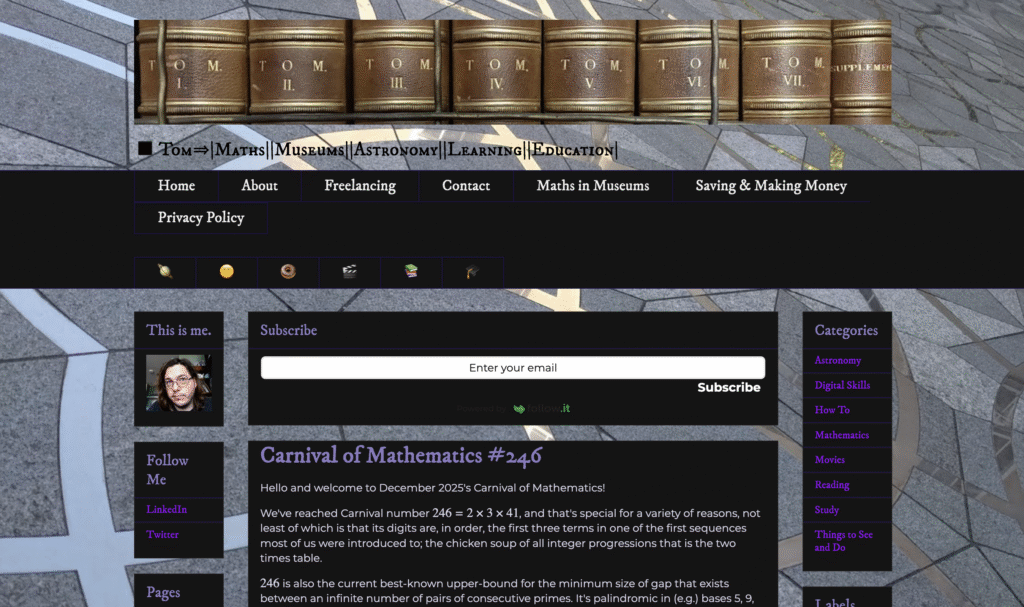L’uso del femminile nelle professioni è un argomento di cui si discute molto (e in maniera piuttosto accesa) in quest’ultimo periodo. Chiara de Fabritiis (coordinatrice del Comitato Pari Opportunità dell’UMI) ne ha parlato con Vera Gheno, una linguista che ha uno spiccato interesse per la comunicazione in rete.
Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!
Nanni Moretti, da Palombella rossa (1989)
Non è comune che Maddmaths! ospiti un’intervista a una persona che si occupa di linguistica, ci spieghi da dove nasce il tuo interesse per la questa disciplina?
Io mi occupo di sociolinguistica: quando studiavo a lettere, alla fine degli anni ’90, ho iniziato a interessarmi a quella che veniva allora chiamata comunicazione mediata da computer. Dal liceo classico mi ero iscritta ingegneria perché non volevo frequentare una facoltà umanistica; in casa mia c’era una presenza debordante di linguistica, quasi una cappa: mio padre tornava a casa e parlava del suo lavoro, anche mia madre è una linguista di formazione. Mi sono però arresa abbastanza presto, passando a lettere; mi è rimasto il pallino per la tecnologia, devo dire per l’analisi e la geometria avevo una vera passione, ma il mio amore per la matematica non era del tutto ricambiato… Non ho continuato con quella strada, quando ho cominciato lettere avevo in uggia le materie più filologiche, la linguistica in realtà si avvicina ai linguaggi formali, del resto Chomsky dice che umanesimo e scienze dure sono uniti e unibili, possono e devono convivere. Si tratta di una materia piuttosto tecnica, fra tutti i suoi settori mi ha attratto la sociolinguistica, perché la cosa che mi interessa di più sono le persone; si tratta di per sé di una disciplina liminale, dato che comprende anche la filosofia del linguaggio, la sociologia, la psicolinguistica.
Come sei arrivata a occuparti di comunicazioni via social?
La sociolinguistica si occupa della relazione fra esseri umani e lingua, di cosa manifestano le persone esprimendosi, fornisce un metodo per analizzare; nella mia attività di studiosa mi occupavo di social networking già prima che si chiamasse così, il nome all’epoca era “comunicazione pubblica (asincrona o sincrona) in rete”. La professoressa con cui mi sono laureata è una sociolinguista giudiziaria ed era molto perplessa sul fatto di dare una tesi su questo argomento, a suo parere si trattava di un fenomeno che sarebbe scomparso abbastanza a breve. Io ci credevo e quindi ho fatto una tesi sul linguaggio dei newsgroup; riguardandola a posteriori mi rendo conto che la lingua dei social è cambiata soltanto nelle manifestazioni superficiali, ma le direzioni di mutamento sono le stesse lette nei primi anni 2000. Quando leggo locuzioni come “la neolingua dei social”, mi viene da dire che non è per nulla una neolingua, dato che se ne parlava già 20 anni fa.
Di cosa ti occupi adesso in particolare?
Ho fatto il dottorato di ricerca proseguendo la mia ricerca sul linguaggio della rete; mi occupo prevalentemente di sociolinguistica qualitativa, non quantitativa, non mi interesso più di tanto di corpora [collezioni, per lo più di grandi dimensioni, di testi orali o scritti, ndr], da cui estrarre informazioni, non guardo tanto alle statistiche, ai dati percentuali, ma seguo soprattutto un approccio etnografico. La rete si è evoluta con me, è uno spazio che abito con serenità, di cui nel tempo ho visto cambiare il panorama. Quando c’è stato il cosiddetto esodo online, in conseguenza del lockdown, io l’ho visto come un evento in cui succedeva quello che è sempre successo, la differenza stava nel fatto che le quantità in gioco erano molto maggiori.
Questo salto quantitativo quando si è verificato?
All’epoca cui ho iniziato, in rete c’erano davvero quattro gatti: si trattava di persone molto preparate, con competenze informatiche e anche linguistiche, perché il grosso della rete non era in italiano, ma in inglese, il gergo della rete era una cosa di élite. Nel 2008 Facebook viene tradotto in italiano, la rete diventa un fenomeno comune anche in Italia, i costumi dell’online cambiano, si perde il valore identitario perché non c’è più bisogno di distinguersi visto che ormai siamo in presenza di un fenomeno di massa, in rete ormai ci siamo tutti, non più un’élite.
Di conseguenza, la rete funziona da strumento di misura delle competenze cognitive dei suoi utenti: i social infatti non hanno peggiorato l’italiano, ma hanno rivelato lo stato delle cose; in particolare rendono evidente a una platea più ampia l’incapacità generale di argomentare, di sostenere una discussione, la mancanza della percezione del fatto che stare in rete significa stare in pubblico.
Questo spiega il perché della modernità della linguistica: come la matematica sembra una disciplina desueta, mentre è estremamente attuale…
il problema principale è che la capacità di comunicare non è connaturata: è vero che, salvo casi particolari, un bimbo impara a parlare in un tempo ragionevole, ma la comunicazione è molto più della mera esternazione, perché bisogna anche considerare l’abilità di esprimersi correttamente.
Proprio per questa malintesa spontaneità, spesso ci sfuggono due cose: la prima è il fatto che la capacità linguistica è come un muscolo, se non si usa va a finire che avvizzisce e quindi va tenuta in esercizio; non si può pensare di campare per tutta la vita sfruttando quello che abbiamo imparato a scuola. Il secondo problema da tenere ben presente è che comunicare è naturale, ma comunicare bene è molto difficile. Infatti non è che la comunicazione funzioni bene in modo spontaneo, ci sono tante variabili che possono andare male, quindi ci vuole impegno per far funzionare bene una relazione comunicativa. La capacità della parola è connaturata negli esseri umani, la usiamo per concettualizzare e se ci riflettiamo bene anche la matematica fa la stessa cosa: non posso capire un teorema soltanto guardando una formula, ho bisogno di spiegazione e quindi di comunicazione. Anche questo è un punto importante: la competenza linguistica serve a tutti, non soltanto ai “letterati”.
Bisogna però rendersi conto che ciò che era opportuno o naturale 30 o 40 anni fa non lo è più adesso: quando nei primi anni ’80 suonavano alla porta quelli che venivano indistintamente chiamati “marocchini”, mia nonna diceva “Dài mille lire al negretto” e quella frase non aveva per lei alcuna connotazione offensiva; adesso la sensibilità è cambiata. Fare ironia sulla “sorveglianza dei costumi femminili”, come è capitato recentemente in rete parlando del “gineconomo”, in un momento in cui si discute tanto sul linguaggio di genere significa non avere il polso della situazione attuale; la replica “Intendevamo essere ironici” peggiora ulteriormente le cose perché scarica la colpa su chi si sente giustamente offeso, vittimizzandolo doppiamente.
Tu ti sei occupata per lungo tempo del profilo Twitter dell’Accademia della Crusca, un’istituzione che nell’immaginario collettivo non ha certo connotazioni giovanilistiche.
Ho collaborato con la Crusca fino all’estate dello scorso anno, gestendone il profilo Twitter, dal 2019 cogestisco il profilo Twitter dello Zingarelli, il vocabolario pubblicato dalla casa editrice Zanichelli.
Devo dire che l’Accademia della Crusca è molto meno parruccona di quanto non si immagini, i computer vengono utilizzati da tantissimo tempo, il professor Nencioni era una persona di grande stile, ma era anche molto interessato all’innovazione. Io ho cominciato a lavorare per loro all’inizio degli anni Duemila, dal 2012 sono stati aperti i profili social dell’Accademia, che quindi si è fatta conoscere anche sotto un’altra luce, però dopo 20 anni per me era ora di cambiare.
La motivazione più contingente di questa intervista è che tu hai scritto un articolo su “Valigia blu” a proposito dei nomi femminili delle professioni link
L’articolo viene fuori da un libro che ho scritto “Femminili Singolari” che nasce molto dalla mia esperienza di gestrice del profilo Twitter dell’Accademia della Crusca. Soprattutto durante la presidenza di Nicoletta Maraschio, la prima presidente donna dell’Accademia, tutte le volte che condividevo qualcosa sulla questione dei femminili professionali si aprivano le cateratte del cielo, per cui ci sono state rivolte accuse di voler creare una neolingua, arrivando fino a minacciarci di bruciare la sede perché dicevamo “la presidente” o “l’assessora”. Quando nel 2016 la Crusca ha partecipato al dibattito sulla liceità del termine “petaloso”, ci è stato detto di tutto, ci hanno detto che eravamo parte del progetto Bilderberg per rovesciare la lingua italiana, ci hanno dato di renziani, per finire con un bel “comunisti di m…a” che non guasta mai.
Inizialmente la questione non mi interessava granché, in realtà io parto come grande scettica, a mio parere i problemi delle donne erano ben altri che non essere nominate al femminile. Due cose mi hanno portato a cambiare idea: prima di tutto l’incontro con alcune studiose del linguaggio di genere, fra cui Cecilia Robustelli che era un po’ il braccio destro di Nicoletta Maraschio su questi temi; ma soprattutto il mio interesse viene dalla veemenza delle reazioni contro l’uso dei femminili professionali.
Mi viene da chiedere “Che noia ti dà se io, linguista, certifico che ministra si può usare?”
Nessuno, salvo i soliti rari scalmanati che ci sono sempre, ha mai pensato di imporre nulla; l’operazione è spiegare che sarebbe più corretto usare i femminili: a livello linguistico fra “maestra” e “ministra”, fra “infermiera” e “ingegnera” non ci sono differenze se non quella data dall’abitudine. Però da questa cosa, che a livello linguistico è lapalissiana, vengono fuori i mostri.
Quanto pesa la componente di reazione aggressiva su questo tipo di argomenti?
Ho l’impressione che sia quantitativamente inferiore a quanto pensiamo, ma siccome tende ad essere violenta si vede maggiormente: le persone che litigano sono meno di quanto sembrano, ma hanno molta visibilità perché urlano. Un problema molto grosso è quello dello hate speech: l’odio si vede di più perché c’è una narrazione mediatica che lo raccoglie. Io penso di non dover evangelizzare nessuno, semplicemente ritengo che in campo linguistico ci siano molte misconcezioni, che andrebbero superate.
Le reazioni a questo articolo ne sono l’ennesima dimostrazione: proprio stamani sono stata taggata su un social e ho discusso con una persona che affermava che “In musica si dice maestro e non maestra, non si può dire maestra”. Andando a vedere nel vocabolario, non c’è nessuna differenza semantica tra maschile e femminile: la nostra percezione di “errore” in questo ambito è dovuta esclusivamente all’abitudine.
Il motivo per cui ho scritto questo pezzo è che mi sembra che siano cose ancora da ribadire al grande pubblico, benché le “Raccomandazioni per l’uso non sessista della lingua italiana” di Alma Sabatini siano del 1987. L’aspetto che manca è quello della divulgazione: a livello linguistico è tutto chiarissimo, ma gli esperti forse dovrebbero occuparsi maggiormente di popolarizzare questo approccio e queste competenze a una platea più vasta; non so come sia la situazione nell’ambiente scientifico…
Ho l’impressione che manchi una certa consapevolezza anche da parte delle donne che appartengono all’ambito accademico, spesso è una posizione che matura con gli anni, all’inizio c’è una forma di ingenuità che non fa notare gli squilibri di genere.
Quello che è importante è la connotazione che noi diamo alle parole perché ci sono due questioni diverse: una è cosa dice il vocabolario, da nessuna parte c’è scritto che è presente una differenza semantica: maestro, direttore, segretario, professore sono tutte parole indifferenti al genere, non si trova scritto da nessuna parte che il maschile si usa per certi ruoli e il femminile per altri. Noi però ci mettiamo una connotazione, legata all’uso, per cui il maschile ha più valore del femminile e quindi la segretaria è quella che prende gli appuntamenti e il segretario è quello di un partito politico; il maestro è quello di musica e la maestra lavora alla scuola primaria. Questo aspetto cambia con il tempo, sono i cascami di una tradizione, come utilizzatori del linguaggio siamo tradizionali e abitudinari e spesso diventiamo addirittura reazionari, cosa di cui bisogna avere consapevolezza.
A cosa serve avere i nomi femminili delle professioni? Perché per alcuni vocaboli si usano certe desinenze e in altri suffissi diversi: un tempo si diceva comunemente “avvocatessa”, adesso si preferisce “avvocata”?
Avere i nomi delle professioni al femminile serve a segnalare che quella professione può essere esercitata dalle donne, è un segnale immediato di accessibilità.
Il motivo per cui si usano suffissi diversi dipende anche dalla storia dell’uso dei vocaboli, la desinenza -essa nasce per indicare “la moglie di” (sindachessa, dogaressa), e in passato è stato usato anche in senso dispregiativo; diciamo che è un suffisso molto femminile; per la linguistica è tutto sommato innecessario, quindi se non c’è un uso abituale e consolidato, come c’è invece in “professoressa”, “dottoressa”, “studentessa” che sono stati creati molto tempo fa e sono ormai stabilizzati, meglio il cosiddetto “suffisso zero” (sindaco-sindaca). Fra i linguisti c’è la convinzione che “avvocatessa” non fosse così diffuso da non poterlo sostituire con “avvocata”, comunque la Crusca, la Treccani sono possibiliste: va meglio avvocata, va comunque bene avvocatessa, peggio un avvocato, se riferito a una donna, da evitare un’avvocato, perché avvocato non è ambigenere, ma è maschile. Già Giovanni Nencioni rifuggiva le forme che lui chiamava ircocervi, animali deformi, come “la ministro”; se proprio si vuole usare il maschile è “il ministro”, però ministra c’era già in latino e non si capisce perché non si possa usare.
Come si può usare in maniera non sessista l’italiano in ambito accademico?
Siccome educhiamo le future generazioni, io penso che abbiamo un ruolo pedagogico; facciamoci delle domande su queste problematiche e possibilmente usiamo i femminili; se proprio usiamo i maschili, meglio non ammantarli con motivazioni scientificamente non valide.
Dal punto di vista linguistico, “professore ordinario” e “professoressa ordinaria” hanno esattamente lo stesso valore, se il secondo ci suona strano è perché un tempo le professoresse all’università erano molto rare; lo scherzo sull’essere “ordinaria” nel senso deteriore del termine funziona anche al maschile perché pure “ordinario” significa “dozzinale”.
Spesso si sente dire che non bisogna chiamare “matematica”, “fisica” o “chimica” una donna che si occupa di queste materie perché c’è il rischio di confondere la persona con la materia; la cosa peculiare è che la polisemia diventa un problema solo quando sono coinvolti i femminili, il che è falso perché nella quasi totalità dei casi il contesto basta per capire; del resto “Ho un fisico eccezionale” o “Sono un fisico eccezionale” non pongono problemi, proprio grazie al contesto. Certo, i cambiamenti non avvengono da un momento all’altro, ci vuole tempo.
Io sono anche molto per il laissez-faire, se una donna che studia matematica mi dice “Io preferisco farmi chiamare matematico”, io le rispondo “Buon per te”; a mio parere non ha senso dire che quella persona sia vittima del patriarcato introiettato. Sono convinta che le persone si possano far ragionare, esporle al pubblico ludibrio perché sbagliano non ha una funzione pedagogica dato che porta alla reazione contraria. Penso che non si debbano imporre le cose, perché in ambito linguistico le imposizioni sono deleterie: le cose si chiariscono, si spiega perché sarebbe meglio usarli, uno degli scopi è proprio normalizzare la presenza femminile in certi ambiti.
L’accademia dovrebbe dare il buon esempio; pensiamo che solo col fatto di entrare in aula e dire “Io sono la professoressa XY e sono una matematica”, è stato lanciato un messaggio molto preciso di presenza femminile. Di recente la rettrice di un ateneo ha detto “Io mi definisco rettore perché i ruoli sono neutri”. Ebbene, non è vero: il maschile non è neutro perché in italiano il neutro non esiste, al massimo si tratta di maschile sovraesteso, ma non è vero che i ruoli siano neutri; basta vedere un vocabolo come “regina”: non mi risulta che Elisabetta I d’Inghilterra o Vittoria sino mai state chiamate re, eppure è un ruolo apicale. Si parla quindi del ruolo di “rettore”, ma se viene coperto da una donna, la si chiama rettrice. Se c’è un nome femminile usiamolo, oppure, se non si vuole usarlo, non cerchiamo motivi campati in aria: basta dire che non ce ne importa nulla, che ci piace di più il maschile oppure che ci suona meglio, ma non usiamo interpretazioni scientifiche senza fondamento.
Qualche consiglio in particolare per le discipline scientifiche
Io incoraggerei l’uso del termine per la persona anche se coincide con la disciplina stessa (matematica, fisica, chimica); usare “matematica donna” è un po’ ridicolo perché è ridondante: si tratta di un calco dall’inglese che però avendo il genere naturale ha il problema del genere solo per i pronomi, quindi segue strategie differenti dall’italiano, infatti in quella lingua si tende a preferire la forma neutra. L’italiano non ha il neutro, il maschile sovraesteso nasconde una parte della popolazione, anche perché, sia in italiano sia prima in latino, i femminili sono stati usati tutte le volte in una posizione lavorativa c’era una donna e quindi non usarli significa implicitamente che non è previsto che una donna ricopra quella posizione. Ad esempio le architette stanno chiedendo il timbro ufficiale con la dicitura “architetta”, in alcune regioni l’ordine professionale lo ha autorizzato, in altre no. Direi che nei settori in cui è presente un ordine professionale introdurre la doppia nomenclatura sia utile (ad esempio, Ordine dei Giornalisti e delle Giornaliste), per lanciare un segnale. Fra l’altro devo dire che spesso gli anziani hanno meno difficoltà, perché non vedono la componente “rivendicazionista”; in generale io credo molto nel cambiamento naturale, non adotterei misure prescrittive.
Per finire, ritorno sulla linguistica: come sono messe le donne in questa disciplina?
Premetto che io sono un po’ ai margini dell’accademia; linguiste ce ne sono molte, ma c’è un collo di bottiglia nelle posizioni apicali dove si vede comunque una prevalenza maschile, non è una situazione facile: come si dice spesso, una donna deve essere più brava dei colleghi per far carriera perché “brava non è mai brava abbastanza”.
Aggiungo che in alcune occasioni sono le stesse donne a nuocersi, per quanto in maniera involontaria: bisogna considerare che c’è un notevole dibattito intergenerazionale su cosa sia meglio fare, quanto sia meglio scegliere una strada più legata al femminismo storico di stampo oppositivo o privilegiare la componente intersezionale; io in quest’ambito tendo ad essere molto pragmatica, sto con chi mi permette di migliorare la posizione delle donne, ma senza pensare che sia un problema cercare di migliorare anche la posizione delle altre componenti a oggi neglette della società.
Intervista a cura di Chiara de Fabritiis
Galleria di copertine di alcuni libri di Vera Gheno