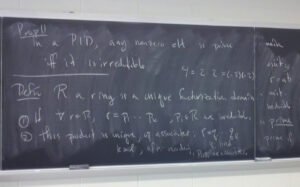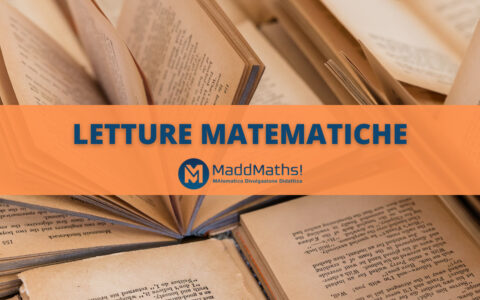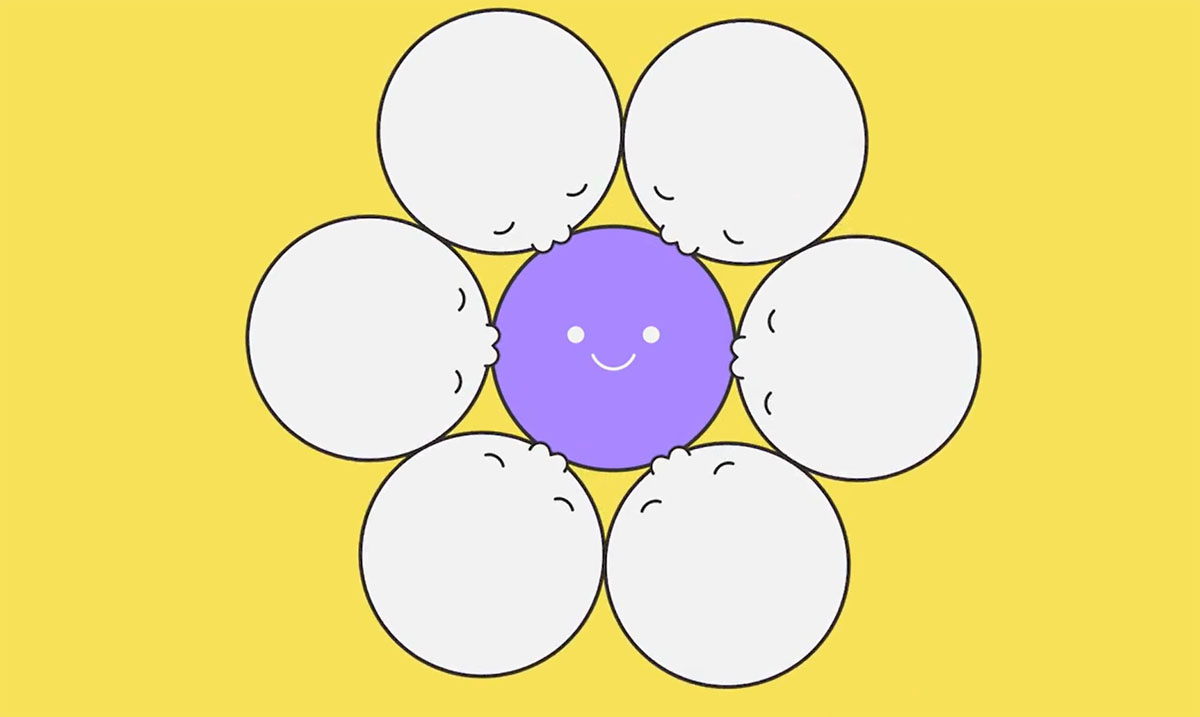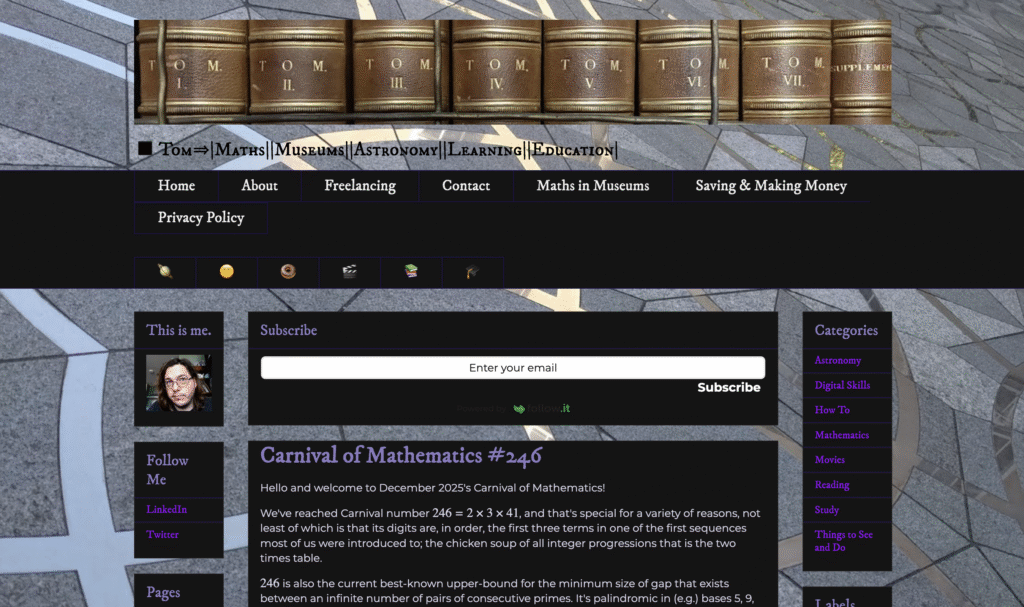Annalisa Murgia è una sociologa generale che ha studiato a Trento conseguendo il dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale, ha poi trascorso un anno all’Università di Louvain La Neuve (Belgio) con una borsa co-finanziata Marie Curie ed è stata in seguito coordinatrice scientifica del progetto FP7 GARCIA – ‘Gendering the Academy and Research: combating Career Instability and Asymmetries’ presso l’Università di Trento. Successivamente si è spostata a Leeds (Regno Unito) come professoressa associata di Human Resource Management and Consulting; dal 2018 è professoressa associata di Sociologia Generale all’Università di Milano e titolare dell’ERC Starting Grant SHARE – Seizing the Hybrid Areas of work by Re-presenting self-Employment. La intervista per noi Chiara de Fabritiis, coordinatrice del gruppo pari opportunità dell’Unione Matematica Italiana,
Non è molto comune ospitare un’intervista a un sociologo su MaddMaths!, per cominciare spiegaci un po’ in cosa consiste il vostro lavoro e il tuo in particolare.
Mi occupo di sociologia generale, che studia i fenomeni sociali e più in generale le forme della vita sociale. In particolare, sono interessata a capire come cambia la cultura del lavoro e i processi di frammentazione e individualizzazione che caratterizzano il mondo dell’occupazione contemporaneo. Quello che conta per me è il modo in cui cambia il senso che gli individui danno al lavoro ed esaminare le differenze e le disuguaglianze, soprattutto quelle di genere. Un argomento di notevole interesse è a mio avviso il tipo di cultura di genere che si sviluppa nei contesti occupazionali; non è qualcosa di legato soltanto al sesso dei soggetti, ma anche al modello organizzativo e al tipo di società. Gli ultimi decenni hanno visto un forte cambiamento del lavoro sia in termini strutturali, sia nella percezione dei soggetti, in particolare si avverte una forma maggiormente individualizzata di relazione con l’occupazione e con l’esperienza professionale.
Potresti spiegare in maggior dettaglio quest’ultima affermazione?
I processi di individualizzazione nel mondo del lavoro sono ambivalenti: come osserva Ulrick Beck in “La società del rischio”, da un lato gli individui devono affrontare in modo individuale i rischi e il proprio destino biografico, per contro si trovano di fronte a un maggior ventaglio di possibilità di scelta rispetto al passato. Questo comporta che si creino processi di responsabilizzazione dei soggetti, per cui per poter beneficiare di un sostegno si deve in un certo senso dimostrare di esserne degno, come se dovesse esistere una “meritocrazia” dell’aiuto. I fallimenti individuali diventano quasi colpe dell’individuo cosicché il lavoro diviene sempre più un processo individuale e non collettivo, a causa della frammentazione dell’esperienza lavorativa e della crisi dei corpi intermedi, sindacati in particolare, dei quali però cogliamo negli ultimi anni dei positivi segnali di apertura alle nuove categorie di lavoratori e lavoratrici, penso soprattutto a chi non ha un lavoro dipendente, dai freelance a chi lavora attraverso piattaforme online.
Sei stata la coordinatrice scientifica del progetto europeo GARCIA ‘Gendering the Academy and Research: combating Career Instability and Asymmetries’, cosa avete studiato?
È un progetto cominciato nel 2014 e concluso nel 2017, che coinvolgeva 6 paesi europei, l’Italia con il ruolo di capofila, Belgio, Slovenia, Svizzera, Islanda, Paesi Bassi, oltre all’Austria che aveva il compito di valutatore interno. Anche dal punto di vista sociologico si trattava di un progetto innovativo, il disegno della ricerca prevedeva che si esaminassero le differenze di genere nella carriera scientifica sia nell’ambito socio-umanistico, sia in quello scientifico-tecnologico. In ogni paese è stata una scelta un’università e in ciascuna di esse un dipartimento umanistico e uno scientifico. In Italia l’università partner è stata Trento, con i dipartimenti di Sociologia e ricerca sociale e di Ingegneria e scienza dell’informazione. Le problematiche di genere sono risultate presenti sia nell’area socio-umanistica sia in quella scientifica. In Italia gli ordinari donna sono pochi anche nei settori socio-umanistici, dove le studentesse sono molto numerose, eppure poche donne arrivano in cima alla piramide. In questo studio ci siamo concentrate sulle differenze di genere all’inizio della carriera accademica, a partire dalle posizioni di postdoc fino ad arrivare ai ricercatori; abbiamo inoltre intervistato i docenti coinvolti in processi di reclutamento. Quello che abbiamo notato nell’arco della durata del progetto è la persistenza di una cultura di genere ancora prevalentemente maschile, che penalizza le carriere delle donne, che hanno tipicamente un sovraccarico di lavoro legato ad attività scarsamente riconosciute ai fini delle progressioni di carriera come la didattica, la supervisione di studenti o attività di tipo organizzativo. L’università resta inoltre un ambiente professionale in cui viene richiesta una dedizione totale al lavoro lasciando poco spazio per dedicarsi alla vita privata e familiare.
Quali particolarità sono emerse in ambito scientifico-tecnologico rispetto al caso generale? E per i matematici nello specifico?
Dobbiamo dire che nelle STEM le cose non vanno bene da un punto di vista delle differenze di genere: il fenomeno del tetto di cristallo è molto presente, unito al minore riconoscimento delle ricercatrici rispetto ai colleghi uomini, come se sulle questioni tecniche il sesso femminile non avesse diritto di essere autorevole.
La ricerca ha seguito le carriere delle persone che hanno ottenuto il dottorato nei dipartimenti studiati fra il 2010 e il 2014, quindi abbiamo intervistato anche coloro che hanno abbandonato la carriera accademica per altri tipi di impiego. Quello che abbiamo visto per chi non è rimasto all’interno del sistema della ricerca è che le possibilità occupazionali sono decisamente migliori per le discipline STEM rispetto a quelle socio-umanistiche. Inoltre, tra le persone occupate in altri settori, sono state molte – sia donne che uomini – ad aver sostenuto di aver lasciato la carriera accademica per raggiungere un miglior equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Per chi invece resta in accademia, in Italia vediamo che le scienze scientifico-tecnologiche hanno un problema molto rilevante dal punto di vista del numero ancora molto ridotto di donne, che non è spiegabile come riflesso della numerosità di studenti donne/uomini. Il desiderio di intraprendere una carriera accademica e la passione per il proprio lavoro possono inoltre portare i giovani ricercatori – e soprattutto le ricercatrici – a restare invischiate in dinamiche perverse. Si tratta del cosiddetto “dispositivo della promessa”, che fa sì che chi cerca di ottenere una posizione stabile nel mondo della ricerca sia disposta ad accettare l’invisibilità del lavoro che svolge (spesso gratuito e attribuito ad altri) in attesa che arrivi il momento del riconoscimento formale. Nel caso del progetto GARCIA non abbiamo indagato il dipartimento di matematica, ma sulla base di altre ricerche possiamo sostenere che le dinamiche sono sostanzialmente le stesse.
Quali altre differenze avete notato fra le discipline socio-umanistiche e le STEM?
Nelle discipline socio-umanistiche abbiamo visto che coesistono due logiche organizzative: da un lato ci sono assegnisti più vecchi, con un percorso accademico tradizionale, che magari non sono mai stati all’estero; dall’altro c’è gente più giovane e con un curriculum maggiormente connotato in senso internazionale. Nel primo caso intervengono le classiche dinamiche di cooptazione, quello che spesso viene chiamato l’old boys network, che è il risultato di dinamiche omosociali e quindi di ordinari uomini che privilegiano le carriere di ricercatori uomini che percepiscono come più simili alla loro esperienza. Nelle STEM invece il modello prevalente sembra essere quello che privilegia il reclutamento di giovani con esperienze internazionali, l’anzianità non viene considerata un valore positivo in sé.
Il vostro progetto è focalizzato sulle carriere a livello iniziale, ma molte matematiche dicono che all’inizio non hanno percepito di avere prospettive peggiori rispetto ai maschi, mentre si sono accorte delle disuguaglianze in seguito
All’inizio della loro carriera le studentesse non percepiscono il problema, anche perché in media hanno risultati decisamente migliori e quindi non avvertono la discriminazione. Un primo sospetto ci dovrebbe venire quando vediamo che il Pantheon di una disciplina annovera solo padri fondatori e nessuna madre fondatrice; l’immaginario viene costruito soltanto su modelli maschili. C’è inoltre una scarsa propensione a riflettere sulle discriminazioni di genere. Nel corso della nostra ricerca, ad esempio, sia nelle discipline STEM che SSH abbiamo riscontrato una tendenza ad attribuire le differenze di genere a fattori esterni all’accademia. Abbiamo avuto risposte come “Certo sarebbe importante che ci fossero più politiche per l’infanzia, perché questo penalizza le ricercatrici”, senza che ci fosse consapevolezza del fatto che alcune dinamiche potrebbero essere soddisfatte dall’organizzazione di appartenenza, come i dipartimenti. Del resto, le donne fanno meno carriera anche se non hanno figli, quindi non è corretto attribuire tutte le differenze alla gestione familiare, perché anche senza figli la situazione non migliora, c’è anche un lavoro da fare a livello culturale.
Una curiosità viene spontanea: come studiosi i matematici tendono ad essere molto collaborativi, quanto lo sono i sociologi?
Una delle differenze più evidenti che abbiamo notato nei due dipartimenti italiani che abbiamo analizzato è che gli informatici sono molto più collaborativi, questo è un comportamento meno usuale nelle scienze sociali: in questo ambito esistono gruppi di ricerca, ma è ancora molto presente il lavoro in larga parte individuale, mentre fra gli scienziati l’uso delle pubblicazioni a firma singola è abbastanza ristretto. Fra i sociologi le collaborazioni non penalizzano, ma persiste l’idea che il lavoro di ricerca sia in larga parte individuale e spesso emerge un rapporto troppo chiuso tra supervisor e dottorando, quasi che quest’ultimo fosse una specie di proprietà privata. La collaborazione permette invece di arricchire le conoscenze attraverso il confronto e che si instauri un meccanismo di bootstrap che permette di superare gli impedimenti talvolta legati alla vita personale, perché se in un certo momento io sono stanco o sono meno concentrato sul lavoro, tu metti l’energia che io non ho e viceversa.
Per concludere, quali caratteristiche a tuo parere connotano il lavoro accademico in quanto tale?
In accademia c’è una cultura del lavoro smisurato, che deriva dal non riconoscimento del proprio lavoro come tale. Questo innesca dinamiche pervasive, per gratitudine si pensa di lavorare senza fine perché ci piace, quello accademico è senza dubbio un lavoro della passione; tuttavia questo crea un senso di colpa fondato sul fatto che non si fa mai abbastanza. È necessario costruire una cultura organizzativa che non sia basata solo sul modello di scienziato a una dimensione e che contrasti i meccanismi di cumulatività che accentrano risorse e riconoscimenti sempre nelle mani delle stesse persone (come osserva Robert Merton). Dobbiamo imparare a gestire i tempi di lavoro con ritmi che consentano di lasciare spazio ad altre attività, e questo è un obbiettivo che si può raggiungere solo collettivamente come studiosi, perché siamo di fronte a un sistema che individualmente non riusciamo a combattere. In Italia le dinamiche di lavoro pervasivo, la flessibilità del lavoro che si estende ovunque sono molto presenti: dato che i limiti non sono posti dall’esterno, devono essere dati dall’individuo. Spesso siamo infatti in presenza di asimmetrie enormi in termini di carico di lavoro, di dinamiche ricattatorie che creano una una strana competizione, non efficace in termini strategici. Io ho lavorato sia in Belgio sia in Inghilterra, e in entrambi i casi ho visto meno storture e contesti più aperti, soprattutto in termini di riconoscimento delle competenze e di divisione dei carichi di lavoro. Tutti sono chiamati a occuparsi di ricerca, didattica e attività amministrative, non c’è chi fa i lavori più prestigiosi e chi invece quelli invisibili o poco riconosciuti, che invece in Italia sono ancora prevalentemente affidati alle donne. C’è ancora moltissimo da fare, ma credo che mettersi in rete, anche provenendo da discipline diverse, sia sicuramente un primo passo per costruire un modello accademico maggiormente equo e privo di discriminazioni.
Intervista da cura di Chiara de Fabritiis








![Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica 2024 – Tutti gli eventi italiani [AGGIORNATO] may12_2024](https://maddmaths.simai.eu/wp-content/uploads/2024/04/may12_2024-300x188.png)