Comunicare la matematica è una questione difficile a cui è dedicato il Carnevale della Matematica di Novembre. Questo il contributo di Nicola Ciccoli.
Ricordo bene i miei primi anni da studente di matematica. La scoperta della debordante potenza dei simboli mi rendeva eccitato e furente. Con determinazione, nel riordinare i miei appunti, cercavo di espungere tutte le parole che mi sembravano non necessarie o comunque sostituibili dai simboli più adatti: gli enunciati dei miei teoremi erano catene perfette di ghirigori il cui significato era privato di ogni ambiguità, le parole ridotte a connettori del discorso, sgraziatamente, a volte, obbligatorie.
L’esercizio costante di traduzione delle lezioni dei miei professori in questo iperuranio del linguaggio era una vera e propria missione; l’imperfetto granello creato dalle lezioni di fisica, dove ogni parola era sopraffatta da una costante ambiguità semantica, non bastava a farmi venire dubbi. Forse il fatto che tra i miei appunti i più popolari siano diventati quelli delle lezioni di Fisica II, lezioni che mi era impossibile tradurre solo in simboli, avrebbe dovuto essere un sufficiente campanello d’allarme.
Credo d’aver imparato molto in questo sforzo di replicare ciò che i professori mi volevano comunicare in ciò che io pensavo la matematica dovesse comunicare.
Al tempo stesso, però, non ero (non lo sono mai stato) immune al fascino dei bei racconti, degli slanci in avanti, delle suggestioni. Ricordo la lezione, era un’assolata giornata di Marzo del 1986, in cui il professore di Geometria I ci parlò della formica che muovendosi sulla retta veniva bloccata da un punto; intuivo con emozione che nel concetto di dimensione c’era più di quanto avessi sin lì pensato. Ricordo quando il professore di Meccanica Razionale aprì una lezione parlando di Pirandello e quando durante il corso sulle algebre di Lie, all’interno di una lezione sulle algebre riduttive, il professore insultò Heidegger dichiarando di preferirgli Husserl. E contribuiva al fascino, inesauribile, di quegli anni in cui tutto ciò che imparavo portava con sé un carico di promesse.
Non so bene, invece, quando inziai a riflettere sul fatto che comunicare la matematica era altro da quelle irte successioni di simboli. Certo due mesi in un Liceo Scientifico, contornato da studenti di soli cinque anni più giovani di me, mi devono essere serviti. Se per me la matematica era stenografia astratta perchè i professori che preferivo erano quelli che mi parlavano anche di letteratura? Perchè i seminari migliori facevano scarso uso di formule e un accuratissimo uso di sottili metafore? Come facevano alcune persone a tradurre equazioni complesse in un linguaggio dinamico pieno di vortici e flussi? Perchè quella loro intuizione riusciva a dargli una marcia addizionale che a me mancava?
Penso c’entrasse molto il fatto che nei primi anni di studio per me la matematica fosse solo un fatto di conoscenza e dopo, solo dopo, si sia popolata di persone. Forse la scoperta del lato umano della matematica è andata di pari passo con l’aprirsi al lato umano della vita.
È stato un processo lento. Oggi non so rinunciare a conoscere i particolari delle vite dei matematici di cui studio e spiego i teoremi, conosco l’importanza del gesto che accompagna una spiegazione, del colore della voce che descrive. Ma riconosco anche che la matematica non è altro che una impresa umana, non c’è in essa nulla dell’iperuranio a cui si appella e molto di sociale. La retorica della verità dura, astra tta, resistente nel tempo, è molto sopravvalutata: così come per l’albero e la foresta è legittimo chiedersi se un teorema scritto in un linguaggio che nessuno comprende continui a essere vero. Per questo non so fare a meno di parlare di matematica, di riempire le mie formule di parole, di ripercorrere a ritroso i miei esercizi di traduzione e trasformare doppie implicazioni in racconti pieni di uomini, animali, sogni, corpi. Per questo devo sempre cercare con attenzione, sia quando parlo che quando scrivo, il delicato equilibrio tra sapere e racconto. Per questo penso che comunicare sia non solo un piacere ma un pezzo essenziale del nostro essere matematici nel mondo.
tta, resistente nel tempo, è molto sopravvalutata: così come per l’albero e la foresta è legittimo chiedersi se un teorema scritto in un linguaggio che nessuno comprende continui a essere vero. Per questo non so fare a meno di parlare di matematica, di riempire le mie formule di parole, di ripercorrere a ritroso i miei esercizi di traduzione e trasformare doppie implicazioni in racconti pieni di uomini, animali, sogni, corpi. Per questo devo sempre cercare con attenzione, sia quando parlo che quando scrivo, il delicato equilibrio tra sapere e racconto. Per questo penso che comunicare sia non solo un piacere ma un pezzo essenziale del nostro essere matematici nel mondo.
Non posso però scordare il terzo vertice di un immaginario triangolo. Riscopro, a volte, il piacere di un silenzio ben detto, mi mordo la lingua in aula e nel vorticare dei pensieri della mia testa mi censuro espressamente. A metà di un seminario affermo, no, questo non ve lo dico, sconcertando gli ascoltatori. Riemerge ogni tanto, in me, una forma di pudore della comunicazione.
In un bellissimo racconto di Borges, nella raccolta “Elogio dell’ombra” un giovane etnografo accetta l’incarico di vivere per due anni in una tribù indiana per conoscere il segreto che viene raccontato solo agli iniziati. Murdok, al suo ritorno, rivela al suo anziano professore di conoscere il segreto ma di non volerlo rivelare pur potendole enunciare “in cento modi diversi e anche contraddittori” e che “il segreto, d’altronde, vale meno delle vie che mi hanno condotto ad esso“. A commento di questo racconto un vero antropologo, Leonardo Piasere, nella introduzione al suo saggio “L’etnografo imperfetto” dichiara che “Il principale strumento di conoscenza sta nella capacità di impregnarsi delle analogie, delle metafore, delle ironie, delle emozioni, delle culture altrui, interiorizzandone il senso più a forza di empatia che di ragionamenti lineari“. Mi sembrano due lezioni distinte e ugualmente valide. La pregnanza di una trasmissione di senso che è sempre processo che collega esseri umani e la forza lineare del silenzio, il rifiuto di comunicare laddove l’eccesso di comunicazione nuoce sia al contenuto che all’esperienza di chi è chiamato al sapere.
Entro così, in aula, in una piovosa giornata autunnale e inizio a scrivere col gesso, in alto a sinistra:
Sia M una varietà differenziabile.
Nicola Ciccoli






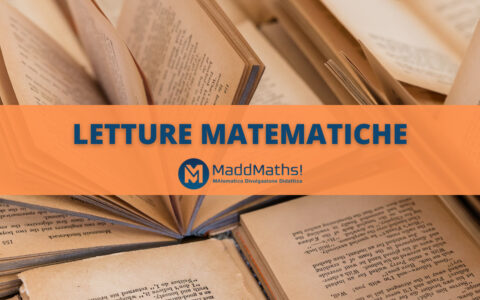





Trackback/Pingback